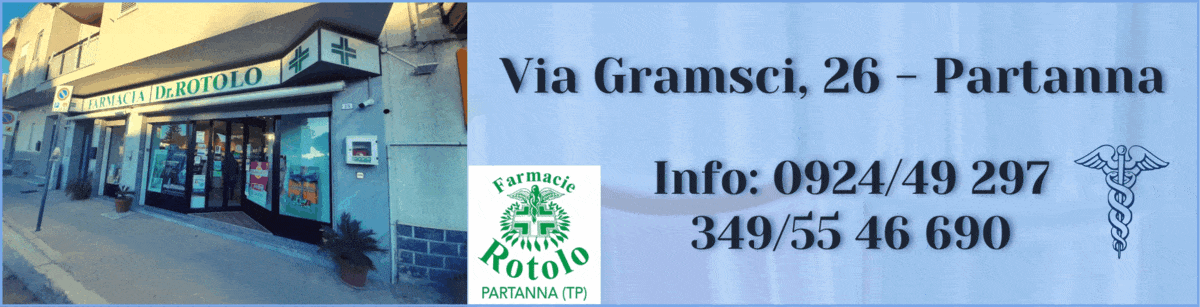Alla scoperta degli antichi mestieri: “lu quarararu” di Campobello tra storia e aneddoti
del 2022-09-07

Lo stagnino o stagnaro era un antico mestiere itinerante. I miei avi, nella nostra comunità a Campobello di Mazara, lo chiamavano “lu quarararu” ed esercitava la propria attività a posto fisso nella centrale via Vittorio Emanuele III, angolo via Umberto I.

Nella stessa via, poco distante, viveva mia nonna Vita: donna esile, minuta, oramai vedova e nutrice di dieci figli, che io quotidianamente andavo a trovare. Mi metteva sulle sue ginocchia e mi raccontava le più belle favole di animali e di stelle che aveva ereditato e tramandava dai ricordi di una sua nonna, con una dovizia di luoghi e di fatti che mi facevano addormentare e sognare. Questo accadeva quando io contavo 7/8 anni di vita: allora si giocava per strada con altri coetanei e la mia attenzione si posava sul lavoro dello stagnino.
Teneva bottega in una stanza con pavimento in battuto di cemento, collocata al di sotto del piano stradale, a cui si accedeva grazie ad uno o due gradini. Nel locale erano sistemate una piccola forgia, un banco in legno dove trovavano posto gli attrezzi, come alcune lime, delle raspe, una serie di martelli di varie forme e misure, forbici per tagliare le lamiere ed un recipiente in vetro, destinato a contenere dell’acido, ed alcune verghe di stagno.

Tutto intorno alla stanza giacevano:“quarare”, “quararunedda”, “cafisi”, una “cazza”, un “placentino” in rame, padelle, vari contenitori in zinco, alluminio e rame, che aspettavano l’intervento del mastro. In particolare, mi ricordo un suo intervento su un oggetto in rame per me curioso e sconosciuto, un cilindro un po’ panciuto centralmente, sormontato da un collo più stretto, al cui centro era situato un buco quadrato, e munito di due manici.
“Mastro Saro” si apprestava a saldare uno dei manici che si era staccato e, mentre era intento all’opera, mi spiegava la tecnica del suo sapere: con la lima piccola raschiava le parti, liberandole da precedenti saldature e riscaldava nella forgia i ferri. La forgia era dotata di un cumulo di carbon fossile che veniva ravvivato attraverso l’aria prodotta da una ventola, azionata a mano da una manovella, che il furbo artigiano mi faceva manovrare, astenendosi dalla fatica e facendomi felice perché scoprivo un nuovo gioco.
I ferri da saldare erano a forma di cuneo ed erano muniti di manici in ferro, con l’impugnatura in legno. Con cura “lu zi Saru” cospargeva le parti da accostare con l’acido, che creava una reazione schiumosa. Impugnava il ferro già incandescente da saldare, ne riscaldava le parti e, accostando la verga di stagno, ne saldava i lembi e poi puliva con uno straccio.
Alla mia domanda di cosa fosse quell’oggetto mi rispondeva: “Chissa è misura di mustu. Stu pirtusu quadratu servi pi fissari la giusta misura di 10 litra”; sotto quell’apertura infatti si leggeva “Lt 10”, scritta punzonata dall’ufficio metrico provinciale, che aveva il compito di controllo di tutte le unità di pesi e misure che venivano utilizzati nei pubblici esercizi.
Con la stessa tecnica “lu quarararu” eseguiva gli interventi sugli utensili in uso all’epoca, ora soppiantati dalla plastica, secondo la scellerata pratica dell’usa e getta. Nei tempi che furono, stimolante era scoprire nuovi giochi, ma più dolce e più bello assai era addormentarmi sul grembo di nonna Vita.
Il Presidente dell'Archeoclub
Campobello Cave di Cusa
Antonino Gulotta