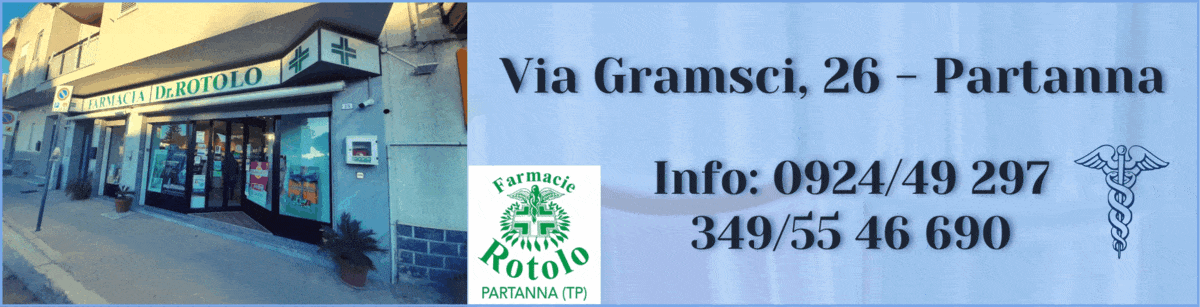C'era una volta il treno a Santa Ninfa, Partanna, Selinunte. Ricordi di un tempo che fu
di:  Vito Marino - del 2016-01-11
Vito Marino - del 2016-01-11

Come nei racconti delle fiabe, quest’argomento bisogna incominciarlo proprio così: "C'era una volta il treno". E’ molto triste ricordarlo, ma nel passato e fino agli anni '60 circa, nella città di Castelvetrano c’era una stazione ferroviaria che, per importanza e traffico era classificata la terza in tutta la Sicilia, dopo Palermo e Messina.

Purtroppo, a causa della politica economica adottata da vari governi, tendente a potenziare il gommato a discapito della rotaia, dopo una serie notevole di tagli, con la chiusura dell’ultima tratta Castelvetrano-Sciacca del 1887, la stazione ha perso il suo prestigio di “diramazione” e si è ridotta ad una fermata, che fra non molto potrebbe scomparire.
La linea “Trapani – Palermo”, a scartamento ordinario, ancora esistente, fu costruita dalla Società Sicula Occidentale e inaugurata il 04//6/1883. Allora era limitata a Palermo “Lolli”.

Lo scartamento ordinario (distanza fra le rotaie di 1435 mm) è uguale in tutti i paesi d’Europa; In Spagna il vecchio scartamento della RENFE è di mm. 1668, mentre le nuove linee si sono adeguate allo scartamento europeo.
In Sicilia, oltre alla rete normale, esisteva una rete ferroviaria complementare a scartamento ridotto (distanza fra le rotaie 950 mm.), che nella sua massima espansione raggiunse lo sviluppo di circa 530 Km. A Castelvetrano esisteva la ridotta “Partanna - Castelvetrano – Agrigento”, e la “Castelvetrano Palermo S. Erasmo”.
La prima, realizzata fra il 1902 ed il 1910 ed aperta al traffico il 26/06/1910, costeggiando il mare, aveva le fermate a Selinunte, Menfi, Sciacca, Magazzolo , Montallegro, Siculiana, Realmonte, Porto Empedocle, Agrigento.
La seconda, attraversava l’entroterra interessando tanti piccoli paesi, una volta abbandonati a se stessi; essa toccava Partanna, S. Ninfa Campagna, Gibellina, Salaparuta, Poggioreale, S. Margherita Belice, Sambuca di Sicilia, San Carlo, Chiusa Sclafani, Bisacquino, Campofiorito,Contessa Entellina, Acqua dei Corsari, Marineo, Chiusa Sclafani, Ficuzza, Corleone, Burgio, Palermo S.Erasmo.
Un'altra piccola linea univa S.Ninfa Campagna con S. Ninfa città e con Salemi. Prima della costruzione della ferrovia, esisteva un servizio pubblico per viaggiatori che da Partanna portava alle stazioni ferroviarie di Castelvetrano e Salemi. Il servizio veniva effettuato con una carrozza a quattro ruote e a quattro posti tirate da due robusti cavalli.
Con lo stesso mezzo si trasportava anche la corrispondenza, i pacchi postali e le raccomandate. Il Deposito Locomotive era provvisto di piattaforma, unica nel suo genere, con quattro rotaie, per poter far girare entrambe le tipologie di locomotive a vapore: a scartamento ordinario e ridotto. Su queste linee secondarie circolavano trenini con vetture molto caratteristiche, che rassomigliavano ai trenini del Far West.
Un intenso traffico animava l’Impianto con circa 2000 lavoratori in servizio stabile che gestivano tutto il lavoro, suddiviso in vari settori.
- Il personale di stazione (intorno alle 100 unità lavorative) era addetto alla circolazione, composizione e scomposizione dei treni (rispettivamente in transito, in partenza e in arrivo), alla gestione merci e viaggiatori, trasbordo merci, segreteria, ecc.
- Il Deposito Locomotive, con più di 300 fra macchinisti e operai, adibito a ricevere e custodire le locomotive non utilizzate e a lavori vari.
- L’Officina, con più di 150 operai era adibita per le grandi riparazioni; con le sue attrezzature e la competenza del personale era in grado di costruire un’intera locomotiva a vapore.
- La Squadra Rialzo si interessava delle piccole riparazioni.
- Una ditta privata, composta di 150 operai, s’interessava alle pulizie dei mezzi di trasporto e all’approvvigionamento di carbon fossile.
- Nel complesso Impianto c’erano anche le sedi del 41° e 11° Tronco Lavori, del Personale Viaggiante, degli Impianti Elettrici.
- Inoltre, esisteva il Posto di Verifica, il Capo Reparto Movimento, il Dirigente unico della linea principale, Dirigente unico della linea secondaria, Dormitorio, Dopolavoro Ferroviario. Numerosi erano i Guardiani addetti ai passaggi a livello. C’era anche una sede della Polizia Ferroviaria.
Una ditta privata “La Paranza”, s’incaricava del trasbordo merci dalla linea normale a quella secondaria e viceversa ed al carico, scarico e consegna colli delle “piccole partite”. Un’altra ditta privata s’incaricava della consegna dei colli a domicilio.
Le gloriose locomotive a vapore, che tanta civiltà hanno apportato nei piccoli paesi sperduti dell'entroterra siciliano, sono state tutte demolite, nessuno si è interessato di lasciarne almeno una, come monumento nella città o nella stessa stazione ferroviaria.
"La paparedda", così era chiamata la locomotiva della linea secondaria a scartamento ridotto, era la 302 e la 301 senza tender; il carbone di scorta era posto nella parte posteriore, mentre l'acqua si trovava nei due serbatoi laterali della stessa locomotiva.
La sua velocità, considerata elevata ai tempi dell’asinello e del carro agricolo, era diventata ridicola con il successivo progresso nei trasporti. Arrivando da Selinunte, a causa della ripida salita incontrata nelle vicinanze di Castelvatrano, il Macchinista annunciava alla stazione il suo arrivo con dei lunghi fischi, per paura di trovare il semaforo d'ingresso chiuso.
Infatti, in caso di fermata in quel punto, difficilmente il treno riusciva a ripartire, poiché le ruote motrici della locomotiva non facevano presa, nonostante la sabbia fatta cadere fra ruota e rotaia (tutte le locomotive a vapore erano dotate di un serbatoio contenente sabbia, da usarsi nelle salite ripide o in caso di ghiaccio sulle rotaie); pertanto, in questi casi, il Deposito doveva inviare una locomotiva di soccorso.
In seguito, dette locomotive, per avere una maggiore autonomia e resa, sono state dotate di un serbatoio suppletivo contenente nafta pesante (nafta arricchita con oli combustibili). L'accensione e la formazione della pressione del vapore avveniva sempre con il carbon fossile; quindi, nella stessa fornace, s’insufflava detta nafta, tramite la pressione stessa del vapore già acquisita.
Anche sulla linea a scartamento normale il mezzo di trazione era a vapore; allora c'era la locomotiva 625 detta: "la signorina", adibita per i treni viaggiatori e la 740 e 741 per i treni merci; inoltre c’erano la 165, la 167 e la 168. Per i treni viaggiatori, sia per la linea normale che per quella ridotta, circolava anche l’automotrice a nafta “la littorina”.
Durante la II Guerra Mondiale, i treni viaggiatori su Palermo si effettuavano, quando era possibile (in media una volta ogni 4 o 7 giorni), compatibilmente con le operazioni militari. Per mancanza di vetture, spesse volte si usavano i carri adibiti al trasporto di bestiame, adattati con panche di legno. Il treno era sempre gremito di persone.
Nel passato, compresi gli anni del regime fascista, la ferrovia era considerata l’arteria della nazione, il simbolo dell’unità d’Italia. Il ferroviere, fino alla II Guerra Mondiale, era il meglio retribuito fra tutti gli impiegati statali; dopo gli anni ’40 anche lui ha seguito lo sfacelo della Nazione, patendo anche la fame.
Con particolare considerazione era tenuto il macchinista, per la sua professionalità ed il duro lavoro. Infatti, prima di salire su una locomotiva, egli doveva avere la qualifica di meccanico ed esercitare la professione all'Officina Riparazioni; questa professionalità gli permetteva di eseguire le riparazioni anche in linea per guasti imprevisti.
Egli per tamponare perdite di vapore e di pressione all’aria compressa, si arrangiava come poteva: con pochi attrezzi in dotazione e con mezzi di fortuna come fili di ferro, stracci, stoppa, gomma di camera d'aria.
Da vecchi macchinisti ho sentito raccontare certi eventi sul loro servizio durante la guerra: fra l’altro capitava di dover lavorare, salvo brevi intervalli, anche per più giorni di seguito, affrontando bombardamenti, spostandosi per esigenze di servizio per tutta la Sicilia e consumando i pasti a bordo, accontentandosi di una bistecca cotta sulla piastra rovente della caldaia.
Il macchinista viveva quasi in simbiosi con la sua locomotiva, nel senso che gliene era affidata una, e svolgeva il suo lavoro solo con quella. Quando aveva il turno di riposo, egli si recava alla Rimessa del Deposito Locomotive e se la controllava, per vedere se le riparazioni da lui proposte nel registro di bordo erano state effettuate e per lucidarsela a festa; in poche parole ne era orgoglioso.
Quest'ultima azione mi fa ricordare il carrettiere siciliano, che nei momenti di sosta pensava subito a pulire carro e cavallo. Il lavoro nella Stazione era enorme, poiché, oltre ai treni in transito, c'erano treni aventi termine e quelli che avevano origine, con continue manovre di carri e carrozze per lo smistamento e composizione dei treni.
Inoltre, poiché le linee secondarie erano a scartamento ridotto, occorreva trasbordare la merce dai carri della linea normale in quelli a scartamento ridotto e viceversa. Bisogna tenere conto che allora l’80% della merce viaggiava su rotaia e il 100% dei viaggiatori usava il treno per i lunghi viaggi.
Per terminare cito una curiosità: quando ero in servizio, ho visto una tromba di rame ricurva come un corno di bue; essa, fino agli anni 40 circa era usata, in sostituzione del fischietto, dai Capi Stazione, per dare il segnale di partenza ai treni.