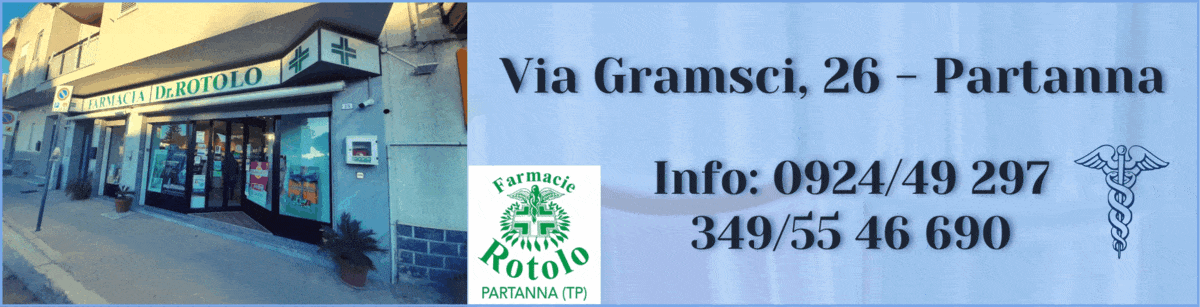Imprenditoria, investimenti e cultura.Carlo d'Aragona e la sua politica finanziaria
del 2017-09-10

(ph. Enzo Napoli)
I pregiudizi e i luoghi comuni - retaggio anche di una cultura formatasi prevalentemente sui sussidiari delle scuole elementari o sul sentito dire - sono duri a morire, anche fra la gente che passa per acculturata. Fra questi preconcetti, nonostante tutti gli sforzi contrari della storiografia siciliana - da Virgilio Titone a Corrado Mirto, da Illuminato Peri a Lina Scalisi – uno di quelli che maggiormente resiste, in una visione priva di qualsivoglia prospettiva storicistica, è quello che vuole a tutti i costi dipingere i baroni siciliani come dei despoti e degli sfruttatori.

Fra questi il Magnus Siculus, quel Carlo d’Aragona, primo principe di Castelvetrano, sicuramente fra le figure più interessanti o, come suol dirsi “intriganti”, del suo tempo. Interprete indiscusso della vita politica siciliana del Cinquecento, successore, nella baronia di Castelvetrano, di Giovanni d’Aragona e Tagliavia, Carlo consolida le fortune della famiglia all’esterno, la inserisce nel gioco politico europeo, ricopre, in nome e per conto del re di Spagna, cariche e responsabilità che lo porteranno fuori dalla Sicilia e dall’Italia, e per tutto questo è giustamente passato alla storia, come detto, con l’appellativo di Magnus Siculus.
Con Carlo, gli Aragona Tagliavia sono ormai tra le più potenti famiglie feudali siciliane, e l’acquisizione del marchesato di Favara e della baronìa di Sant’Angelo Muxaro, grazie al matrimonio di Giovanni, figlio di Carlo, con Maria de Marinis più che a consolidarne ulteriormente il potere, servirà loro come nuova fonte di reddito. Gli orizzonti della famiglia si allargano ormai oltre i confini dell’Isola.
Già, delle cinque figlie di don Carlo, le tre ultime avevano sposato dei signori napoletani. Il nipote ed erede dello stesso nome sposa una Pignatelli e Colonna, il pronipote Giovanni una Gonzaga di Guastalla in prime nozze ed una Mendoza, spagnola, in seconde nozze; e finalmente, Diego, fratello di Giovanni, prende in moglie una discendente di Ferdinando Cortes, il leggendario conquistatore del Messico. Signore splendido e munifico, don Carlo conferma nei suoi atti quanto cospicuo fosse il suo patrimonio di famiglia.
Nel triennio 1574-76 (era allora presidente del Regno), don Carlo spende mediamente 15.196 onze all’anno, così ripartite: per salari il 7,6%; per cavalli l’8,2%; per vestiti il 9,9%; per le spese straordinarie il 16,1%; per le uscite correnti per la casa il 37,8%; per il resto il 10,6%. Tali dati confermano il ruolo rilevante delle spese di rappresentanza e di pompa.
A differenza della nobiltà isolana, indebitata per esborsi al di sopra delle proprie possibilità, don Carlo poteva permettersi un tale stile di vita perché, nel suo caso, le entrate superavano le uscite (la media delle entrate nel triennio 1574-76 era di onze 19.364, contro le 15.196 di uscite). I suoi redditi sono cospicui e in continuo incremento.
A Castelvetrano, il reddito lordo dei pascoli, gabelle civiche, mulini e censi passa da onze 1354.6.8 nel 1556-57 a onze 2356.26.18 nel 1576-77 (+75%) e a onze 2975 nel 1594-95 (+125%), mentre l’affitto di Borgetto e Belìce, feudi che si utilizzavano soprattutto per la semina, passa da onze 1200 nel 1562-63 a onze 3560 nel 1594-95 (+197%). Anche a Terranova, altra baronìa degli Aragona-Tagliavia, tra il 1562-63 ed il 1603-04, il reddito lordo aumenta da onze 2400 a 8002, risultando più che triplicato.
In quaranta anni, tra il 1555-56 ed il 1590-1600, complessivamente, i redditi degli Aragona-Tagliavia, duchi di Terranova e prìncipi di Castelvetrano, si triplicarono: in parte per il contemporaneo aumento del prezzo del grano, che raddoppia; in parte per l’aumento della rendita fondiaria che in alcuni terreni cerealicoli della Sicilia centro-occidentale, cui quelli degli Aragona-Tagliavia possono assimilarsi, mostra un aumento reale (hl di grano/ha) del 100%. Nel 1560-61, don Carlo è in grado di dare in mutuo alla regia corte, cioè allo Stato, onze 2680,24 al 15%.
Lungi dallo stereotipo del signore latifondista e assenteista, don Carlo nella gestione di feudi e baronìe conferma la perfetta conoscenza delle risorse delle sue terre e mostra duttilità nella scelta della politica di sfruttamento delle stesse. A Castelvetrano, sceglie l’enfiteusi, quasi una rinuncia alla proprietà, poiché le terre vengono assegnate per periodi prolungati (anche vent’anni) ad equo censo, per cui il borgese poteva introdurre culture che richiedevano più tempo per entrare in produzione piena, ma poteva ben godere, dato il periodo lungo di cessione, del momento favorevole della produzione fino al suo esaurimento. Fu così che il vigneto, poco alla volta, prese il sopravvento sul grano.
A Terranova, invece, prevale il terraggio (contratto per cui il colono cede annualmente parte del raccolto al proprietario) e permane la monocultura del grano, mentre il barone resta padrone della terra. Che l’enfiteusi si andasse sempre più estendendo a Castelvetrano viene confermato dall’incremento dei censi. Questi, dai 162 scudi del 1556-58, passano ai 362 del 1573-87 e ai 972 del 1597: si intensifica, in tal modo, la penetrazione del capitale urbano nei campi, avviando quella che può definirsi una vera riforma agraria ante litteram.
In sostanza, a Castelvetrano sono gli assegnatari delle terre ad investire nelle stesse per incentivare la produzione, mentre a Terranova è il principe a svolgere questo ruolo. Sfruttando la favorevole congiuntura dei prezzi, don Carlo realizza a Terranova, fatto eccezionale tra i feudatari dell’Isola, miglioramenti fondiari nei suoi feudi, costruendo la diga di Grotticelle per irrigare le terre e aumentare la produzione di grano; realizza mulini, vende l’acqua ai massari, conseguendo notevoli guadagni. Avvia la realizzazione del lago Biviere, trasformando l’omonima salina, dirottandovi le acque del fiume Dirillo.
E anche questo investimento ha un immediato ritorno con l’istituzione della gabella della pescheria. In ambo i casi, i sistemi adottati dal principe incentivano l’accorrere di coloni che portano ben presto a notevoli incrementi le popolazioni dei due centri: a Castelvetrano, gli abitanti passano dai 10.229 del 1540 ai 13.000 del 1599; a Terranova, dai 4578 del 1548 ai 6724 del 1605.
Precisi calcoli economici portano don Carlo a cedere in affitto alcune sue baronìe (Borgetto e Belìce ai genovesi Pier Gregorio Lomellino nel 1573-75 e Giambattista Giustiniani nel 1576-81, e a Giorgio Tagliavia dal 1584) e contemporaneamente a entrare in compagnia per l’affitto di feudi del territorio di Corleone, dove manda a pascolare i suoi cavalli per alcuni periodi dell’anno, o per l’affitto di intere e grandi baronìe, come a Mazzarino, in società con un mercante nobilitato di Messina, dal 1573-74 al 1575-76; o a Partanna, in società con un mercante di Castelvetrano e il già citato Giorgio Tagliavia, dal 1568-69 al 1579-80, con l’interruzione di un anno.
La sagacia del principe si dimostrò ancora nell’accorta gestione dei suoi capitali allorché, costretto, in ragione della sua consistenza economica, a pesanti esborsi per le doti di paraggio delle figlie, spesso, pur disponendo, in ambito familiare, di capitali liquidi, ricorreva all’istituto della soggiogazione, allo scopo di far gravare i debiti sul patrimonio feudale, giacché l’inflazione in corso (e ciò fino agli anni Venti del ‘600) el’aumento del valore reale della rendita coprivano nel tempo l’ulteriore indebitamento.
Esponente dell’apparato, abile amministratore dei suoi feudi, spregiudicato fautore di società alle quali dà incisività operativa con l’apporto dei suoi capitali e del suo peso politico, questi è l’uomo che, il 18 ottobre del 1566, assurge alla carica di presidente del Regno (in tal modo si designava la dignità vicereale quando veniva affidata a un regnicolo); e già i primi atti del suo governo palesano gli intenti riformatori da cui era animato.
Comincia, appunto, col regolare in una famosa Prammatica le eccessive spese che si era soliti sostenere per le onoranze funebri, proibendo i cosiddetti repiti, cioè l’utilizzo, ancora largamente praticato, dei lamenti delle prefiche davanti il letto del defunto. L’opera di Carlo si indirizza quindi, nella seduta parlamentare del 14 giugno 1567, alla riforma del sistema di riscossione fiscale, allora affidata ad una miriade di deputazioni che provvedevano a mezzo di commissari, spesso corrotti, alla riscossione materiale dei donativi.
Il fatto che i deputati potessero operare al di fuori del controllo del viceré, che potessero riunirsi come e quando volessero, che in numero ridotto potessero decidere per tutti gli altri assenti, costituendo veri centri di potere e spesso di opposizione al viceré, tutto questo indusse don Carlo a sciogliere le diverse deputazioni per raggrupparle in un’unica “Deputazione del Regno”. La riforma di Carlo fu poi completata, nel 1570, con l’abolizione dei commissari e la costituzione di tre regi percettori a salario fisso.
Significativi furono gli interventi del principe di Castelvetrano nella realizzazione di un vasto programma di opere pubbliche e di riforme urbanistiche che segnano una svolta nella Palermo del tempo. L’ampliamento e la rettifica del Cassaro (olim via di Toledo, oggi via Vittorio Emanuele) videro protagonista don Carlo, il quale ebbe il ruolo di catalizzatore volitivo e determinante di un processo maturato in quegli anni che vide il senato palermitano dotarsi degli strumenti urbanistici necessari all’esecuzione, e nel viceré Garcia de Toledo il grande propugnatore del progetto, come anche dell’altro, non meno rilevante, della realizzazione del molo.
Assente il viceré, che, in quanto capitano del mare, era impegnato nella lotta contro i pirati barbareschi, don Carlo ebbe il merito di dare il via, senza indugi, a quanto, in qualche maniera, era stato già predisposto, dando slancio a un meccanismo che attendeva solo di essere innescato e che, una volta avviato, trovò rapido compimento: non solo ampliamento e rettifica del Cassaro dal Palazzo Reale alla chiesa di S. Antonio, come era stato predisposto, ma addirittura prolungamento, voluto da don Carlo, fino alle absidi di N. S. di Porto Salvo; ed anche apertura del largo che dal casato del principe si disse d’Aragona, ossia di quella piazza Bologna (poi Bologni) che, tangente al Cassaro, dava a questo un momento di pausa e di respiro.
Nel contempo, don Carlo gettava la prima pietra del molo nuovo, determinante a quell’ampliamento del porto che, dopo l’interramento delle foci dei due fiumi che cingevano l’antico nucleo della città, ridotto alla stretta cala, non consentiva un adeguato asilo alle navi mercantili, penalizzando i commerci e le attività di un grande centro portuale quale Palermo aspirava ad essere, e di una armata numerosa qual era quella che il Toledo nel porto poteva concentrare, ma che l’angustia di questo impediva.
Nel 1568, a don Carlo succede il viceré Francesco Ferdinando Avalos marchese di Pescara; ma alla sua morte, avvenuta nel 1571, il re Filippo II torna a nominare il principe di Castelvetrano. Grande era la fiducia che il re di Spagna riponeva in Carlo, testimoniata com’è dal lungo carteggio di corrispondenza intrattenuto dai due. Nella scelta, da parte del re, di porre un siciliano al vertice del governo dell’Isola, e per un periodo così lungo, non fu estranea, comunque, l’esigenza della corona spagnola di assicurarsi, nella lotta contro il Turco – alla quale il governo di Carlo contribuì con l’enorme somma di 1.600.000 scudi – il sostegno, ritenuto fondamentale, dell’aristocrazia del Regno, di cui i Tagliavia Aragona erano i rappresentanti più eminenti e più ascoltati.
La prima questione che il re affida al nostro principe è relativa ad una spinosa controversia con la Santa Sede, concernente il Tribunale della Monarchia. Era questo l’istituto attraverso il quale si esercitava la cosiddetta “apostolica legazia”, privilegio concesso da Urbano II al granconte Ruggero nel 1097, con la bolla Quia propter prudentiam tuam; in forza della quale, il re di Sicilia si considerava capo della chiesa isolana, di cui nominava direttamente i vescovi.
Ovviamente, nel corso dei secoli, la Santa Sede non aveva perduto occasione per ridimensionare o annullare la grave limitazione che all’autorità del Papa derivava dalla bolla di Urbano II, e d’altra parte il potere politico cercava di mantenere tale significativa prerogativa. Famosa rimase a tal proposito la cosiddetta “controversia liparitana” del 1711.
Orbene, l’occasione per ribadire polemicamente i diritti dell’apostolica legazia fu l’introduzione dei decreti del concilio di Trento, che in Sicilia furono applicati secondo le rigide interpretazioni del Tribunale della Monarchia, a cui concorsero eminenti giuristi siciliani, quali il Gisulfo, il Raimondetta, il Gambacurta, chiamati proprio da Carlo d’Aragona. Si deve quindi al principe di Castelvetrano l’aver tracciato una sorta di linea di resistenza all’attacco curiale, promosso, nel clima della crociata antiturca, contro la prerogativa siciliana.
Tale atteggiamento si riscontra del pari anche nelle vicende che videro Carlo contrapporsi, come già il padre Giovanni, alla Santa Inquisizione. Un iniziale episodio, durante il primo mandato di presidente del Regno, concerne un orefice, tale Antonio Bertini, famiglio del Sant’Uffizio, che il principe aveva fatto imprigionare senza tener conto dell’immunità del foro di cui lo stesso godeva; per quel fatto, il duca di Terranova fu costretto a pagare all’orefice 200 ducati di risarcimento oltre a sottoporsi a pubblica penitenza.
Durante il secondo mandato, don Carlo continuò la politica del suo predecessore, volta a difendere i diritti della monarchia siciliana contro le ingerenze pontificie (in particolare, contro la bolla In Coena Domini di Pio V, sulla proibizione di nuove imposte) e contro l’arroganza del nuovo inquisitore, Bernardo Gasco, che, nell’assumere il proprio ufficio, si era astenuto dal presentare e chiedere l’esecutoria della patente di nomina.
Protagonista attivo della politica siciliana del secondo Cinquecento, don Carlo è promotore ed interprete di quel “nazionalismo isolano” che assegna alla Sicilia un ruolo preminente nella politica di difesa dei domini spagnoli e dei confini della cristianità nel Mediterraneo. È la Sicilia riparo et antemurale contro il Turco – scrive egli a Filippo II - suggerendogli il rafforzamento delle difese dell’Isola, il potenziamento della flotta, una politica di attiva presenza in Africa, sottolineando al re di Spagna il ruolo che, in tale contesto, la classe dirigente isolana era disposta a svolgere, coincidendo una tale linea con le sue aspirazioni e prospettive del momento: Sicilia magazzino ed arsenale della flotta cristiana, stimolazione attraverso le commesse militari del mercato interno.
Don Carlo ha in proposito le idee molto chiare: La vera difesa et sicurezza di questo et altri regni… dipende dalla risolutione, et diligenza di unir molto per tempo l’ armata sua nel porto di Messina: percioché se bene il numero della gente et cavalli (…) è grande, non di meno la poca disciplina et concerto, il quale in così breve tempo non si può mettere fra loro, toglie il fondamento che sopra tale massa si potesse fare; et la forza del servitio militare et della militia del regno, consiste più nell’opinione, che negli effetti, per essere la gente comandata mal pratica et mal industriata, et i cavalli mal atti à fattioni, et à travaglio….
D’altra parte, le truppe di mestiere, soprattutto le spagnole, oltre che costare all’erario, erano pur sempre motivo di timore e di insofferenza per la popolazione, che malvolentieri le accoglieva nelle città, dove il diritto di posata veniva sopportato come una maledizione; e ben lo provavano Catania presso cui, dopo Lepanto, furono alloggiate alcune compagnie (molti abitanti si allontanarono dalla città per non subire quella convivenza), e Marsala, costretta, per tutto il ‘500, a ricevere milizie - ora in partenza, ora provenienti dal nord Africa, spesso non pagate e perciò predisposte ad ogni sopruso sulla popolazione - che, finalmente, fu preservata da quel difficile connubio, grazie alla costruzione di un quartiere destinato alle truppe che, all’interno di quella struttura, poterono trovare ricetto (per esse c’era perfino la cappella) e vivere appartate dai cittadini; quartiere che, proprio sotto la presidenza di don Carlo, fu completato e divenne funzionante, come una lapide, ancora sul posto, conferma e ricorda.
Giunta la notizia della vittoria delle armi cristiane alle Curzolari, il principe convocò un Parlamento straordinario, il 24 febbraio 1572, allo scopo di chiedere ulteriori donativi per contribuire alle immense spese che il re cattolico aveva sostenuto per difendere i suoi stati. Si dedicò quindi a restaurare le fortificazioni del Regno, e, a Palermo, fece costruire il baluardo della Concezione, il cui tracciato si estendeva dalla chiesa del Noviziato a porta Carini e che, fino alla sua distruzione, iniziata nel 1932, era appunto chiamato il bastione di Aragona.
Nel 1573, diede mano alla riforma della milizia del Regno, fissandone la consistenza in 10.000 fanti e 1.600 cavalieri, stabilendo che vi contribuissero sia le città o terre baronali, sia quelle demaniali, dividendo la Sicilia in dieci sergenzie (o terzi), e assegnando a ciascuna terra o città un contingente di fanti e cavalli, distribuiti in compagnie. Costituì, ancora, un corpo speciale di 400 cavalieri, al comando del proprio figlio, marchese di Avola, affinché fosse pronto a venire in soccorso alle città marittime del Val di Noto, più esposte alle incursioni dei barbareschi.
Per far fronte alle spese occorrenti all’impresa che Filippo II progettava contro Tunisi, Carlo convocò il Parlamento siciliano nell’aprile del 1573 e, ottenuti alcuni sussidi, fece allestire ventidue galee ben armate e le spedì a Giovanni d’Austria per accrescere l’armata cristiana di cui era comandante. Nel 1574, dopo l’effimera conquista cristiana di Tunisi, essendo minacciata la nostra Isola dalla flotta turca, don Carlo non esitò a guidare personalmente la cavalleria siciliana verso Trapani, al fine di prevenire un minacciato sbarco barbaresco in Sicilia.
Scampato il pericolo, il principe di Castelvetrano continuò a farsi promotore di una spedizione cristiana in Africa che, tuttavia, non poté essere approntata per le gravi condizioni dell’erario spagnolo. Va detto che la politica finanziaria di Carlo, in sintonia con l’assestarsi della struttura patrimoniale della grande feudalità isolana, fu ispirata dall’avversione per la vendita degli uffici e dall’ostilità al ricorso a mutui o anticipazioni da mercanti.
Egli preferì rendere perpetue alcune imposte, come quella sulla macina o sulle pelli, e fare affidamento al rialzo delle tratte frumentarie. Il principe saggiamente optò per forme di indebitamento che offrissero la possibilità tecnica di un rapido riassorbimento. Poiché forte era il peso economico delle importazioni, che si sopportava soprattutto per l’acquisto delle armi (ricordiamo che l’economia siciliana era gravata in larga parte dalle spese militari) e della polvere, che giungevano dalla Lombardia, don Carlo propose che si istallassero fonderie a Messina e a Palermo. L’apparato militare, necessario in Sicilia nella strategia di difesa dal Turco, viene quindi visto in modo lungimirante, come una adeguata risposta al crescente pauperismo e come vitale stimolo all’asfittico mercato interno.
Nel 1574, Carlo fece sistemare la piazza Pretoria, dove fu collocata dall’architetto Camilliani la mirabile macchina d’acqua che il senato palermitano aveva comprato per l’enorme somma di 68.192 scudi. Altro intervento urbanistico fu la creazione del Borgo Santa Lucia, in prossimità del nuovo molo. Intanto, nel 1575, Carlo d’Aragona dovette fronteggiare il gravissimo flagello della peste, che si protrasse fino al luglio del 1576. Rigorosi provvedimenti, sia nella profilassi, sia nella repressione dei delitti, dovettero essere adottati dal presidente del Regno, allo scopo di fronteggiare il contagio, nel corso del quale ebbe a distinguersi il medico palermitano, di origine regalbutese, Gian Filippo Ingrassia.
Ricordiamo che Carlo d’Aragona aveva sperimentato di persona la valentia del medico di Regalbuto, allorché, colpito in un torneo, fu tra la vita e la morte. La ferita, tra la sesta e settima costola dell’emitorace sinistro, andò incontro ad un grave processo suppurativo che richiese il consulto dei più insigni medici italiani ed europei, quali il Vesalio, allora archiatra di Filippo II, l’Eustachio e quasi tutto il collegio romano. Tuttavia, le loro cure non sortirono l’effetto sperato.
Fu l’Ingrassia, che sperimentò empiricamente sul principe le proprietà terapeutiche del guaiaco (detto anche legno santo), ad apprestare i rimedi opportuni per la guarigione della fistola, successo che salvò don Carlo e accrebbe la stima e la fama di questo grande medico. Altri parlamenti furono ancora convocati nel 1576 e nel 1577, allo scopo di votare i soliti donativi per contribuire alle spese di guerra del re cattolico, impegnato non solo contro il Turco ma anche nelle Fiandre. Il principe, secondo il costume del tempo, “cercò sempre con sopraffina politica – scrive il Di Blasi – di allontanare dagli abitanti ogni trista memoria, tenendoli occupati in Giostre e Feste”.
Si rimembrano, in particolare, i pubblici festeggiamenti in occasione della venuta a Palermo del cardinale Alessandro Farnese, nel 1567, e, qualche mese dopo, quelle per l’inizio dei lavori del molo. Memorabile fu, ancora, il solenne ingresso di don Giovanni d’Austria, l’11 febbraio 1572; in quest’ultima occasione, le cronache narrano di come il principe di Castelvetrano volle dar prova della sua destrezza, misurandosi con l’illustre ospite al gioco della canna, che consisteva nell’imbroccare con una lancia un anello sospeso a una fune.
Si ricorda, inoltre, quanto accadde nel 1576, allorché, cessata la peste e iniziata, come adempimento di un pubblico voto, la costruzione della chiesa di S. Rocco, si giunse a una vera e propria forma di culto della personalità – temperata invero dall’orgoglio civico – col plateale gesto di murare, assieme alla prima pietra del sacro edificio, anche una serie di medaglie d’oro, d’argento e di bronzo, che raffiguravano da un lato l’effige di Carlo e dall’altro il triscele, simbolo della Sicilia.
Era come se si perpetuassero, dopo due anni, i fasti per l’unione della figlia di don Carlo, Anna d’Aragona, con Giovanni III Ventimiglia, marchese di Geraci, nozze che vennero a rinsaldare i rapporti tra le due casate. Tale avvenimento, da una parte, si può ritenere un interessante esempio di tipica festa privata della classe aristocratica cinquecentesca, dall’altra, proprio per la carica pubblica che il Magnus Siculus deteneva, assunse il tono di vero e proprio evento di Stato.
Non a caso, il rito religioso si svolse nella cappella del palazzo del principe, prerogativa questa riservata esclusivamente alla famiglia reale, di cui gli Aragona Tagliavia si consideravano propaggine. Alla mente del non più giovane Carlo tornarono forse, in quella occasione, i ricordi del suo matrimonio, certo meno fastoso di quello della figlia, ma pur sempre consono al rango delle famiglie che in quell’evento furono coinvolte: il rampollo degli emergenti Aragona Tagliavia impalmava un’esponente di antica nobiltà siciliana, donna Margherita Ventimiglia dei marchesi di Geraci. Era l’ultimo dell’anno 1547, e Carlo si era recato, assieme al padre e al suo seguito, da Palermo a Castelbuono, nuova capitale dei Ventimiglia sulle Madonie, per celebrare il suo matrimonio con donna Margherita.
I festeggiamenti durarono fino all’Epifania, e quindi i novelli sposi rientrarono a Palermo, scortati da un corteo di nobili e di dame splendidamente vestite. L’avvenimento fu ricordato dal famoso matematico del tempo, il messinese Francesco Maurolico, presente alla corte di Giovanni Ventimiglia, fratello della sposa, col quale condivideva interessi e progetti.
Trascinato dalla sua vena poetica, il Maurolico volle esaltare le virtù della sposa e il valore dello sposo con due sonetti celebrativi, ancora oggi conservati tra le sue Rime. Riprendendo il filo del nostro discorso, ricordiamo, inoltre, che si deve a don Carlo la raccolta delle Prammatiche e dei Capitoli del Regno, iniziativa che consentì di potere riunire in una sorta di testo unico le disposizioni principali dell’ordinamento giuridico siciliano, fin ad allora sparse e disarticolate. Esse furono stampate, a cura di Raimondo Raimondetta, in Venezia nel 1574.
Soddisfatto dei suoi servigi, Filippo II chiamò il nostro principe a Madrid, per impiegarlo in delicati affari di Stato. Nell’aprile del 1578, don Carlo e la sua famiglia si imbarcarono sulla galea Palermo, mentre il seguito di cavalieri (tra cui il famoso umanista Antonio Veneziano) e religiosi trovò posto su un’altra galea, la Sant’Angelo, che andava di conserva. Fu quello un viaggio disastroso e funesto, giacché le due navi furono intercettate, presso l’isola di Capri, da una squadra di corsari algerini; il principe riuscì a stento a sottrarsi ai pirati, mentre le navi furono catturate e i suoi uomini fatti schiavi.
Sia come sia, Carlo giunse a Madrid, dove si pose a disposizione di Filippo II che lo inviò, quello stesso anno, al congresso di Colonia per ridurre all’obbedienza le province della Fiandra; nel 1579, lo troviamo, assieme al genero Ercole Branciforte, conte di Cammarata e duca di S. Giovanni (che aveva sposato la figlia Isabella), nella legazione a Praga presso l’imperatore Rodolfo d’Asburgo; nel 1581, fu creato viceré del principato di Catalogna e delle contee di Rossiglione e di Cerdagna; l’anno seguente fu inviato nello stato di Milano come governatore e, nel 1589, venne delegato a concludere una lega fra il re cattolico e i cantoni della Svizzera; tprmato in Ispagna, fu quindi presidente del Consiglio d’Italia, l’istituzione attraverso la quale la monarchia gestiva gli affari degli stati italiani.
Sempre consultato dal sovrano in delicate e spinose questioni politiche, insignito delle più alte onorificenze, Carlo d’Aragona e Tagliavia moriva a Madrid, nella sua casa junto a San Martin, nel 1599. Basterebbe a illustrare la singolarità del personaggio la lettura del voluminoso inventario dei suoi beni, redatto en la villa de Madrid il giorno 27 settembre 1599. In più di cento pagine, troviamo un elenco impressionante di mobili, vasi, argenti, parati, stoffe, carrozze, libri, suppellettili, biancheria ed altro, che riflettono, nella loro variegata provenienza e nella loro preziosità, la varietà degli interessi e il profilo dinamico e cosmopolita di questo principe.
Mancava dalla Sicilia da più di vent’anni anni, ma in Sicilia volle tornare, almeno da morto. Nel testamento - rogato due anni prima della sua fine e in cui nomina come esecutori delle sue ultime volontà soltanto personaggi siciliani - dispone infatti che il suo corpo debba esser sepolto nella chiesa di san Domenico di Castelvetrano, nella tomba dove riposava il corpo della duchessa, sua amata sposa; ordina poi che, malgrado la lunghezza del viaggio, il suo cadavere non sia aperto per mettervi dentro aromi o altro, ma sia lasciato tale e quale e così seppellito.
È significativo il fatto che non avesse assegnato alcun obolo a chiese o istituti spagnoli, ma solo di Castelvetrano e Palermo. Alla Casa professa dei Gesuiti di quella città lascia cento onze, all’ospedale di S. Bartolomeo e alla Badia dei ripentiti z. 40 ciascuno; a Castelvetrano, lega al convento di S. Domenico 40 onze annuali, a quello dei Cappuccini una elemosina, al monastero dell’Annunziata e all’ospedale z. 40 ciascuno; a tutte le confraternite e compagnie di Castelvetrano z.10 ciascuna.
Dei suoi domini nell’isola, Castelvetrano fu dunque la città prediletta; qui fissò la sua dimora, qui pose la sede dell’amministrazione delle città a lui soggette - Avola e, soprattutto, Terranova - e dei vari territori limitrofi, Pietra Belìce, Burgio Milluso, etc. Prima ancora di assumere la guida del governo, nel 1546, Carlo aveva fondato il convento dei Cappuccini in contrada Sant’Anna, dotandolo di preziose reliquie (tra cui un lembo del velo della Santa) e assegnando ai frati una rendita per il vitto e per il vestiario.
A proposito dei Cappuccini, la figura di don Carlo richiama alla memoria la famosa vicenda di fra’ Pietro da Mazara. Questo santo fraticello, che discendeva dalla nobile famiglia mazarese degli Emanuelli, aveva seguito, nel 1550, la spedizione militare di don Giovanni de Vega, viceré di Sicilia, contro i barbareschi di Tunisia. Ammalatosi di peste, fra’ Pietro era stato imbarcato per far ritorno in Sicilia; ma, durante la traversata, si dice che il Crocifisso, che soleva portare sempre con sé, gli avesse parlato rivelandogli che sarebbe morto prima di approdare a Trapani.
Il cappuccino confidò la predizione ricevuta al comandante della nave, pregandolo di non gettare in mare il suo corpo, come abitualmente avveniva, ma di affidarlo all’ammiraglio di Sicilia, don Carlo d’Aragona, affinché lo facesse seppellire nel più vicino convento del suo Ordine. Il principe consegnò dunque la salma del venerabile Pietro ai Cappuccini di Castelvetrano, mentre il miracoloso Crocifisso fu esposto alla pietà dei fedeli. Il culto della sacra effigie si sviluppò con incredibile rapidità, anche per le numerose grazie che cominciarono ad esserle attribuite.
Nel 1549, don Carlo crea per sollievo di poveri e miserabili persone il Monte di Pietà coll’assignamento che fece detto Ecc.mo Signore con altri dinoti Cittadini di alcune rendite, come leggiamo agli atti di notar Antonio Abitabile al 1° gennaio di quell’anno. Nello stesso tempo, viene istituita la Compagnia dei Bianchi, formata da cittadini del primo ceto, tanto per la cura dell’infermi, quanto per conforto e assistenza de Miserabili condannati a morte… assegnando all’istessa per oratorio la riferita chiesa di Santo Antonio.
La compagnia dei Bianchi teneva l’amministrazione del monte di pietà e dell’ospedale, il cui complesso occupava gli odierni fabbricati adiacenti alla chiesa di Sant’Antonio Abate, compresa l’area dell’odierno mercato ittico, dove sorgeva una cappellina dedicata a S. Rocco, patrono degli appestati.
l nome di Carlo è inoltre legato alla fabbrica della Chiesa Madre, di cui, nel 1552, fa completare il campanile (che, tuttavia, rimase privo della merlatura) ad opera dell’architetto Giovanni Gandolfo, come leggiamo nell’epigrafe di pietra tufacea, ancora decifrabile nella torre campanaria: ILL.S D.NI D. CAROLI ARAGONE ET TAGLAVIE COMITIS CASTRIVETERANI ET MARCHIONIS HERACLEE NEC NON ET HVIVS POPVLI IMPENSA FACTA EST HEC TVRRIS CIMBALARIA MANV MAGISTRI JO. GANDOLFI ARCHITECTI A.D. 1552
(Questa torre campanaria fu fatta a spese dell’ill.mo signore don Carlo d’Aragona e Tagliavia, conte di Castelvetrano e marchese di Eraclea (Terranova) nonché di questo popolo, per mano del maestro architetto Giovanni Gandolfo, nell’anno del Signore 1552). Nel 1558, Carlo d’Aragona ottiene il giuspatronato della Matrice, il diritto cioè di presentare l’arciprete. E fu un Tagliavia, don Simone, a ricoprire la carica di primo arciprete de jure patronatu; mentre Carlo assicurava alla chiesa un beneficio annuale di 35 ducati d’oro, a condizione che si cantassero le ore canoniche e si amministrassero gratuitamente i sacramenti al popolo.
Il conte, per migliorare il servizio divino, provvedeva alla nomina e al beneficio di quattro cappellani perpetui e di due deputati per il governo temporale. Altri contributi vennero versati dalla consorte, donna Margherita Ventimiglia (z. 10), mentre cittadini, tra i più eminenti della città, diedero il loro obolo, oltre ad assumere l’onere di mantenere alcune cappelle della chiesa; infine, il popolo tutto, con la gabella della primizia (tt. 1.10 a famiglia) e poi con quella della foglia (denari tre per ogni tarì sopra la vendita della verdura e della frutta) - gabelle temporanee, ma abolite solo nel 1842 - contribuì a che la chiesa fosse completata nella struttura e negli adorni e vi fosse svolto il culto con dignità e decoro.
La politica ecclesiastica di Carlo favorì la venuta a Castelvetrano di altri due ordini religiosi: Carmelitani e Agostiniani. Nel 1556, era stata fondata la chiesa di N. S. dei Miracoli, lungo la via che dall’Annunziata portava verso il convento dei Cappuccini in Sant’Anna. Attiguo alla chiesa, nel 1569, i Carmelitani eressero il loro primo convento in città.
Quest’Ordine ne erigerà un altro in adiacenza alla già citata chiesa quattrocentesca di S. Nicolò, che una venerabile confraternita amministrava da tempo. Questa, con atto rogato presso il notar Orlando Lo Truglio al 18 settembre 1584, cedette la chiesa all’Ordine carmelitano, con l’obbligo di mantenervi il culto. Da allora, al vecchio titolo di S. Nicolò si affiancò e divenne prevalente quello di N. S. del Carmine.
Successivamente, come per atto ai rogiti di notar Vincenzo Graffeo ad 8 ottobre 1623, steso a seguito di determinazione capitolare presa in Marsala a 3 settembre dello stesso anno, i frati del convento dei Miracoli, ridotti in piccolo numero, si fusero, anche per l’insalubrità del sito in cui il loro convento sorgeva, con quelli di S. Nicolò.
Sorsero, tuttavia, contrasti esterni tra detti frati e gli Agostiniani, per questioni di precedenze nelle processioni, che si trascinarono a diversi livelli giurisdizionali per circa quattro anni; e contrasti interni tra le due componenti carmelitane in riferimento all’attribuzione delle cariche conventuali. Pertanto, verso il 1640, le due comunità religiose tornarono a dividersi; il convento dei Miracoli condusse vita grama e fu tra i primi ad essere soppresso nel 1774.
Nel 1565, l’illustre famiglia Maio, i cui esponenti manifestavano già la loro vocazione a divenire “uomini del principe”, dava un primo saggio di tale processo di affermazione nel patriziato locale, fondando la chiesa di S. Agostino, provvedendo successivamente alla sua dotazione, come da atto in notar Orlando Lo Truglio a’ 22 maggio 1578. Alla chiesa fu aggregato un convento agostiniano, la cui fabbrica fu ultimata nel 1584. Per quanto concerne S. Domenico, sua chiesa prediletta, si rimanda al predetto intervento di A. Giardina.
La preoccupazione di Carlo fu certamente diretta anche a rendere più fluida l’amministrazione della città. Si è a lungo ripetuto, anche da chi scrive, sulla scorta di quanto sostenuto dal Noto, che egli avrebbe fissato in 40 il numero dei consiglieri, attribuendo ventiquattro seggi al primo ceto, dodici a quello degli artefici, quattro ai borgesi. Altro pensiero del principe fu quello dell’approvvigionamento idrico, volto a portare in città l’acqua di Bigini.
Di don Carlo conosciamo l’immagine attraverso una medaglia fatta coniare in suo onore nel 1575, che viene riportata nella vecchia edizione della Storia cronologica dei Viceré di Sicilia del Di Blasi. Essa reca nel diritto il busto del principe e la scritta: CAROLVS ARAGONIVS MAGN. SICVLVS. Inoltre, in due tavole di Palermo, una proveniente dalla chiesa di San Rocco, ed oggi conservata al Museo Diocesano, e l’altra nella chiesa di Sant’Agostino, opere attribuite entrambe all’Alvino (sia pure non senza contrasti per assegnazioni al Wobreck o al Fondulli), riscontriamo le sembianze del grande siculo. Ben altro si potrebbe dire di questo primo principe di Castelvetrano, cosicché rimandiamo al volume di Lina Scalisi (“Magnus Siculus”. La Sicilia fra impero e monarchia (1513-1578), Roma-Bari, Laterza, 2012), fondamentale saggio che dovrebbe attentamente essere letto, soprattutto da parte di chi, prima di avventurarsi in strampalate analisi pseudostoriografiche, dovrebbe sentire il bisogno di un minimo di documentazione.
F. S. Calcara
V. Napoli
A. Giardina