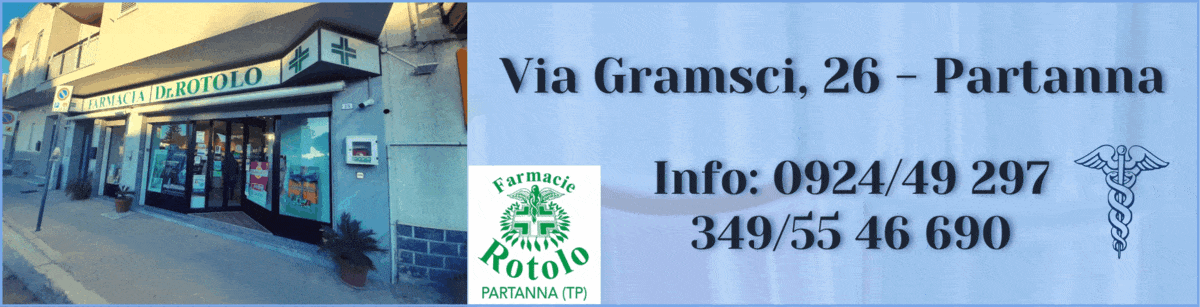"La vita, la morte e l'eutanasia". Si può decidere di morire?
di:  Vito Marino - del 2016-04-04
Vito Marino - del 2016-04-04

(ph. http://www.nonsprecare.it/legalizzazione-eutanasia-suicidio-assistito-valore-vita)
Nel corso di lunghi millenni di storia, l’umanità si è posto sempre il problema dell’esistenza, della morte e dell’aldilà. Infatti, l’umanità non può arrendersi alla morte, come fine di tutto e cerca di immaginarsi un aldilà fatto a proprio uso e consumo.

Durante la preistoria i vivi credevano ad una sopravvivenza dei loro defunti, dal momento che le tombe contenevano tracce di alimenti e di utensili destinati ad essere usati dai defunti inumati.
A partire invece dal Paleolitico Superiore (40.000 a.C.), si aggiunse un trattamento speciale del corpo del defunto, che veniva coperto di ocra rossa, simbolo del sangue e dunque della vita, con una particolare cura della testa e l'applicazione di conchiglie nelle orbite oculari, segni di una nuova visione, e strumenti sempre più numerosi accanto al corpo del defunto, il che sta a indicare che non si doveva entrare nell’aldilà privi di bagagli.
Verso il 10.000 a. C., vicini ai centri abitati troviamo dei cimiteri, segni di un legame tra i vivi e i morti, una corrispondenza d’amorosi sensi, ebbe a dire il Foscolo, che continua ancora oggi.. Per risolvere questo gravoso enigma tutte le religioni predicano una seconda vita dopo la morte, vita intesa in senso spirituale, ma molto spesso una vita materiale simile a quella già vissuta.
Un problema molto antico, che sta tra la vita e la morte rimane l’eutanasia o dolce morte, per come qualcuno la vuole impropriamente chiamare, che viene riesumato ogni qualvolta si presenta un caso pietoso di sofferenza umana, come avvenne per Eluana Englaro, di 38 anni di Lecco, rimasta in coma per 17 anni a causa di un incidente e anche per il caso di Pier Giorgio Welby.
Un altro caso d’eutanasia che ha fatto discutere e trepidare il mondo intero è stato quello di Terri Schiavo, “giustiziata” il 31/3/2005, sia pur legalmente e democraticamente, su richiesta del marito, che, essendo ancora giovane, si è voluto togliere quella pesante palla dal piede e formarsi una nuova famiglia.
In questi casi estremi citati venne praticata la morte assistita. L’eutanasia, è stata effettuata sin dall’antichità anche in Italia. Il suo vocabolo che fa ancora inorridire le persone un poco sensibili, deriva dal greco: eu = buono e thanatos = morte; pertanto = buona morte.
Si tratta di una teoria medico-giuridica secondo la quale è lecito dare agli infermi atrocemente sofferenti ed inguaribili; una morte tranquilla, staccando la spina, per come comunemente si sol dire o per mezzo di narcotici; una condizione ancora oggi giudicata inammissibile dal punto di vista del diritto positivo attuale e della morale cristiana.
La chiesa Cattolica, la Luterana, l’Episcopale, l’Evangelica e quella Fondamentalista partendo dal principio che la vita e la morte ci vengono date da Dio, da tempo si erano dichiarate contrarie all’eutanasia ed al suicidio assistito.
L’eutanasia fu praticata nell’antichità dall’antica Sparta che, avendo bisogno di soldati sani e forti, eliminava i bambini deboli o malati, in quanto non potevano diventare dei buoni soldati. L’idea venne ripresa dalla Germania nazista, dove fra il 1938 e il 1945 numerosi bambini deformi o mentalmente tarati furono soppressi.
In Italia, nella cultura della vecchia civiltà arcaica contadina già esisteva la concezione dell’eutanasia e veniva da qualche parte attuata in pieno.
In un libro che ho letto di recente “La mia isola”, l’autrice Giovanna Casapollo, di origine Castelvetranese, parlando di un personaggio sardo “accabbadora” (da accabbari, che in sardo, ma anche in siciliano, significa finire), scrive testualmente: - <<S’accabbadora aveva svolto correttamente il suo compito, aveva dato la dolce morte al povero vecchio interrompendo la sua agonia e la sua sofferenza […]
Tzia Nunzia la vecchia accabbadora con “sa mazzola” aveva inferto il colpo mortale sulla fronte del nonno precipitandolo nel sonno della morte e liberando lui e la sua famiglia dalla sofferenza della vita, che non si arrende al tempo>>.
La scrittrice così continua nella sua narrazione: <<Seppi che tutti sapevano e che nessun senso di riprovazione esisteva nei confronti di questa pratica e di chi l’attuava. Tzia Nunzia era considerata in paese una sorta di “missionaria” che si faceva carico materialmente e moralmente di porre fine alle sofferenze del malato e alle fatiche della famiglia, che si allontanava discretamente dopo avere svolto il suo compito, senza ricevere alcun compenso, se non la gratitudine dei familiari.
Lo stesso Parroco del paese, pur sapendo dell’esistenza di questo particolare personaggio, non aveva mai preso provvedimenti nei suoi confronti. Nessuna scomunica da parte della Chiesa; in pratica era un’accettazione tacita di uno stato delle cose, un personaggio a cui tutti prima o poi potevano far ricorso in caso di necessità>>
Da mie ricerche effettuate in Sardegna presso parenti, ho potuto costatare che ciò corrisponde a verità. Anche la scrittrice Dolores Turchi nel suo libro “Accabadores” parla di questo personaggio. Da un’altra mia ricerca su questo argomento son venuto a conoscenza che in Sardegna si prevedeva la morte rituale degli anziani che avessero superato il settantesimo anno di vita.
A rendere più spregevole il rituale che con la morte poneva fine al dono della vita di un anziano, che non poteva rendersi più utile alla famiglia, la pratica prevedeva che il padre settantenne venisse accompagnato dal figlio, probabilmente il maggiore che ne avrebbe poi fatto le veci, presso un dirupo o un baratro a seconda di ciò che la morfologia del territorio offriva.
E’ probabile che l’anziano non presentasse lamentele, poiché i rituali erano pienamente prevedibili. Ancora oggi a Gairo è comune sentire la frase “is beccius a sa babaiecca”, (i vecchi alla babaiecca) un vocabolo originato da “babai”, che significa padre.
Babaiecca è effettivamente una roccia a picco distante più o meno un chilometro dalla vecchia Gairo e tradizionalmente si ritiene che quella fosse il luogo in cui anticamente il rituale si svolgeva. La gola profonda otto metri e ricerche recenti paiono affermare il fatto.
Anche ad Ovodda è stato possibile riscontrare resti tradizionali di questo costume. Si racconta che gli anziani che avessero superato i settant’anni venissero precipitati dalla rupe detta localmente “su nodu de lopene”.
Identico discorso potrebbe farsi per Cossoine a Sassari dove è presente una pietra nota con il nome di Su Mammuscone; la tradizione ancora viva nella memoria vuole che un tempo dal dirupo venissero lanciati gli anziani che avessero superato i settant’anni di vita o le mogli infedeli.
L’importanza del sito è comunque rivelata dal suo stesso nome, che ricorda molto da vicino quella di una divinità sotterranea.
Il rituale del geronticidio, che si adatta molto bene a quella che doveva essere la società sarda durante il neolitico, in ambiente prenuragico aveva la proprietà di rigenerare la vita dell’assassino e potrebbe riconnettersi facilmente con l’antropofagia del defunto.
Consumarne le carni significava assumerne caratteri, capacità e doti del defunto. Il rituale doveva essere sentito anche come un obbligo morale, visto che se l’anziano fosse morto di morte naturale, tutte le qualità che lo avevano caratterizzato in vita, sarebbero andate perdute.
Se la morte fosse avvenuta in forma violenta, l’uccisore ne avrebbe assorbito le qualità a garanzia della sopravvivenza della società.
Ad essere uccisi, per come afferma Giovanni Lilliu, scrittore, saggista, giornalista sardo, non dovevano essere tutti gli anziani che superavano i settanta anni, ma solamente quelli particolarmente importanti a livello societario, capi tribù o saggi, le cui qualità fisiche e morali non potevano essere perdute.
In Sicilia nel passato nelle preghiere si chiedeva a Dio sempre la “buona morte”. Allora, per l’analfabetismo e l’ignoranza, si credeva che tutte le malattie provenissero dalla “pigghiata d’occhiu”, un maleficio fatto da persone che volevano del male ad un’altra persona; pertanto si procedeva tramite un rito, a scacciarlo via.
Quando l’ammalato terminale soffriva molto e la morte tardava ad arrivare, si ricorreva alla magia per accelerare i tempi e risparmiare sofferenze.
A tale scopo sotto il capezzale si mettevano delle forbici (che simbolicamente tagliavano il filo della vita) oppure il morso (ferro della briglia dei cavalli) oppure sotto il letto si metteva “lu iuvu” (il giogo dell’aratro) forse perché i due componenti si incrociano a forma di croce.