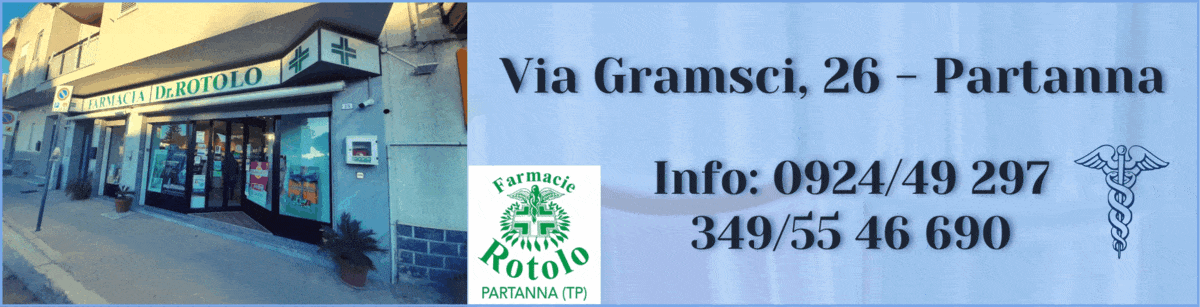Oggi si festeggia San Giuseppe. Tra cibi e usanze la tradizione va avanti
del 2015-03-19

(ph. foto di repertorio)
La devozione del popolo per tutta la Sacra Famiglia e per San Giuseppe in particolare, è stata sempre sentita da tutta la popolazione. In particolare San Giuseppe è stato venerato come protettore dei falegnami, delle ragazze nubili e degli orfani. Storicamente è noto che nel 1030 furono i Benedettini per primi a celebrare il culto di San Giuseppe. In seguito furono “i servi di Maria”, nel 1324 e i Francescani nel 1399.

La prima chiesa dedicata a San Giuseppe sorse nel 1129 a Bologna. Il culto di San Giuseppe Patriarca incominciò a celebrarsi nel 1030, come ricorrenza nel 1479 sotto il Papa Sisto IV, che lo inserì nel calendario per il giorno 19 marzo. Pio IX l’otto dicembre 1870 proclamò San Giuseppe Patrono universale della Chiesa Cattolica. Nella Valle del Belìce la devozione per San Giuseppe inizia nel XVIII secolo, ma le radici affondano nelle celebrazioni pagane legate al culto di Demetra prima e poi di Cerere, entrambe divinità delle messi, che in Trinacria, per secoli granaio d’Italia, furono particolarmente venerate. Quindi, festa cristiana in onore di San Giuseppe e pagana propiziatoria per un buon raccolto, messe assieme.
A Castelvetrano, una volta, la confraternita dei falegnami, s’incaricava della Sua festa. Da una donna anziana ho appreso, ma ne ho avuta conferma da altre fonti, che ad iniziare dal 1° mercoledì dopo l'Epifania e fino alla ricorrenza, si festeggiava il Santo in chiesa con "li mercuri sulenni" e "li mercuri vasci". I primi, finanziati con i soldi raccolti fra i fedeli, con funzioni più solenni; i secondi, celebrati gratuitamente dalla chiesa, erano meno appariscenti. In quelle occasioni si cantava "lu viaggiu di San Giuseppi" con accompagnamento d’organo e violino e si recitava "lu rusariu di San Giuseppi". Durante la funzione dei mercuri vasci si celebrava anche “lo sposalizio di San Giuseppe” Alla fine della funzione, avveniva lo sparo dei “mascuna” (mortaretti), “tammurinata” e “scampaniata”, tre manifestazioni che hanno da sempre accompagnato le principali feste religiose. Si tratta d’espressioni esteriori barocche che fanno da contorno alle ricorrenze festive religiose, molto sentite dalla popolazione. In merito un proverbio antico dice: -“Nun c’è festa senza parrinu e mancu senza tammurinu”-.

La ricorrenza si festeggiava nei giorni 17, 18 e 19 Marzo. Nei primi due giorni, la gente portava fiori in chiesa al Santo, che veniva posto su un altare molto in alto con una scalinata piena di candele accese. La chiesa era “apparata” (addobbata) con lunghi drappi colorati ornati con fregi e angeli dorati, tutto un gusto barocco, molto usato durante le festività religiose più importanti. Per i primi due giorni nella Via V. Emanuele (la strata di la cursa) si assisteva alle corse dei cavalli, molto seguita dalla popolazione. In onore di San Giuseppe, mia madre, davanti al presepe di Natale, recitava “lu rusariu di San Giuseppi” e cantava “lu viaggiu di San Giuseppi” Dei due brani conservo le parole ed il motivo (che ho trascritto in musica). Nel pomeriggio del giorno 19 iniziava la processione del Santo per le vie della città.
Alla processione partecipavano i “fratelli” della confraternita dei falegnami e bottai, che portavano delle aste sormontate dalla figura di San Giuseppe, vestiti tutti di bianco, con saio, cappuccio e visiera. C’erano sempre “li virgineddi”, bambini vestiti da angeli che portavano i “gigli bianchi di San Giuseppe”. Il corteo era preceduto dai “tammurinara” e seguiti dalla banda musicale. Alcuni fedeli, che avevano fatto promessa al Santo per ricevere grazie, camminavano a piedi scalzi e portavano i ceri accesi in mano. Il Santo veniva posto sul carro ornato di fiori e piante verdi.
Durante il percorso, come avveniva nelle processioni principali, i fedeli preparavano “lu posu” (una sosta), con un altarino coperto di una tovaglia bianca ricamata, un’immagine sacra e tanti fiori e vasi di foglie d’ombra ai lati. Al rientro della processione, verso la mezzanotte, si sparava “lu iocu di focu” (i fuochi d’artificio). Dalla data del terremoto 1968 la processione non si era più fatta (tranne qualche rara eccezione). Quest’anno (2015) si farà di nuovo per interessamento dell’amministrazione comunale e della Pro Loco. Per quanto riguarda la tradizione del “votu, l’artaru e cena”, era scomparsa del tutto per alcuni decenni, a decorrere dal terremoto del 1968; da alcuni anni è riemerso per iniziativa privata, ma anche dell’amministrazione comunale.
Quest’anno (2015) ammirevole è l’iniziativa spettacolare della Pro Loco per questa bellissima manifestazione . Secondo la tradizione, quando una persona bisognosa, pregando il Santo chiede una grazia, può fare promessa di una festa in Suo onore a grazia ricevuta: “Lu votu” al quale seguirà: “mmitu, tavulata ed artaru”.
Anzitutto, se è stato specificato nel votu, anche se benestanti, si deve raccogliere il denaro fra la popolazione come segno di umiliazione e penitenza “Ci dati nenti pi San giusippuzzu?” questa era la frase generalmente usata. “Lu mmitu” consiste nel mettere in atto la promessa fatta invitando “la Sacra Famiglia” in casa propria, dove già è preparata la “tavulata” (la tavola apparecchiata) e “l’artaru”. Questa "Sacra Famiglia", invitata alla “tavulata”, una volta era scelta fra le persone più bisognose, a cui mancava addirittura il pane per sfamarsi, oggi è scelta fra volontari per allietare la festa.
Così, questa regola dura di frugalità veniva interrotta in quel giorno, con un banchetto composto da più di “centu e una pitanza”. Tutti prodotti ricavati dalla campagna e cucinati in tanti modi. Era il massimo che la povertà di allora poteva offrire ad un santo per la grazia ricevuta. Quando ero bambino, a Castelvetrano (anni ’50) la mattina della festa del Santo, vedevo passare in processione: "Don Mariddu lu tammurinaru" (Mario Pompei), che si dava da fare a percuotere il tamburo per attirare l'attenzione della gente.
Al suo seguito c’era una duplice fila di fedeli specialmente amici e parenti della famiglia celebrante, con i ceri accesi, quindi seguiva "la Sacra Famiglia" con: “San Giuseppe” (un vecchietto appoggiato ad un lungo bastone con il giglio fiorito, una tunica turchese che lo ricopriva fino ai piedi e la testa inghirlandata), la “Madonna” (una ragazza con una lunga veste celeste ornata con ricami e merletti) e “lu Bomminu” (Gesù, un bambino vestito di bianco, fermato ai fianchi con nastro azzurro).
Alcune verginelle (delle bambine avvolte di bianchi veli e con il giglio in mano), completavano il gruppo; Questo corteo, dopo avere girato per alcune strade del paese, si dirigeva verso la chiesa del Santo, per una funzione religiosa, quindi si recava ospitante (di chi aveva fatto il voto). La casa si riconosceva per i rami di palma posti sul davanzale. Per rispettare il cerimoniale, la Sacra Famiglia trovava la porta chiusa. San Giuseppe bussava alla porta e dall’altra parte era chiesto: “Cu è? soccu vuliti?” (Chi è? cosa volete?).
La risposta era: “Su tri poviri piddirini, chi addumannanu arrisettu” (sono tre poveri pellegrini che chiedono sistemazione). Siccome nessuno apriva, la scena si doveva ripetere tre volte; alla terza volta di dentro domandano “vui cu siti?” e di fuori rispondono: “Gesù, Giuseppi e Maria”; a questa risposta la porta si apriva al grido di “Viva Gesù, Giuseppi e Maria” e clamorosi applausi.
Tutto questo cerimoniale serviva a ricordare quando la Sacra Famiglia bussò tre volte per avere ospitalità. A mezzogiorno in punto, dopo che il prete aveva dato la benedizione, si serviva il pranzo in una stanza adiacente all'altare, in una tavola lunga coperta d’una tovaglia bianca, mentre fuori si sparavano "li mascuna".
Ancora oggi, secondo la tradizione, sul tavolo del banchetto, accanto a ciascuno dei “Santi” invitati, sono posti tre pani di diversa forma. Davanti a “San Giuseppe” è posto un pane a forma di bastone, simbolo della saggezza; davanti alla “Madonna” un pane a forma di palma, simbolo della pace. Infine, davanti al “Bambino Gesù” è posto un pane a forma di sole, simbolo della Signoria di Cristo sull’universo.
La prima pietanza del banchetto è rappresentata dall’arancia, seguono gli assaggi di un’infinità di pietanze, come la “Pasta di San Giuseppe”, frittelle varie di verdure, ortaggi e frutta di stagione, pesci, uova (niente carne perché è periodo di quaresima); infine, ci sono i dolci di tutte le varietà in uso nel paese come pignulati, minnulati, sfinci, cannola, cassateddi, cassati, dolci a base di ricotta, nonché molti altri a base di pasta di mandorla.
Durante il pranzo le pietanze sono servite a tavola da tre ragazze da marito, mentre gli “invitati” non devono toccare il cibo, ma vengono serviti in bocca con le posate, come atto di umiltà e penitenza che fa parte della promessa fatta con il “votu”. Ad ogni portata, servita a tavola, c’è un rullo di tamburo con “evviva Gesù Giuseppe e Maria”, con la risposta di tutti “evviva”.
La cerimonia può durare diverse ore. Servito il pranzo, si scioglie il voto, ma davanti all'altare continuano le preghiere ed i canti dedicati a San Giuseppe, ancora per una diecina di giorni; i numerosi fedeli, che vanno a fare "lu visitu", ricevono come dono "panuzzi" artisticamente lavorati, e dolci.
Di sera tardi, fra tutti coloro che hanno partecipato alla riuscita di tutta la manifestazione si consumava un ricco banchetto. Ma oltre ai panuzzi per l’altare, per la ricorrenza di San Giuseppe si preparavano dei grossi “cucciddati” (a forma di ciambella) di semola di grano duro. Questi pani di San Giuseppe, che raggiungevano anche il peso da 5 a 8 kg, avevano una preparazione particolare. Dopo averli preparati a forma di grossa ciambella, con lavorazione ornamentale di dentro e di fuori, si “squaravanu” (si immergevano in grande “quarare” (caldaie) di rame con acqua bollente, si infarinavano e si lisciavano per coprire eventuali spaccature e si ponevano in teglie unte di sugna e si infornavano. Ne usciva fuori un pane molto duro, ma friabile allo stesso tempo, che durava molto nel tempo anche fino a maggio. Il pane si appendeva con uno spago ad una trave, dopo averlo avvolto da un “cannaveddu” (una tela rustica usata per gli alimenti). Il pane si usava per accompagnare le zuppe invernali di legumi od ortaggi. Siccome nella bocca del forno non entrava, la consuetudine prescriveva la rottura della stessa. (questa notizia mi è stata fornita da Angelo Sciroppo un cultore delle tradizioni popolari). Il pane dell’altare, assieme ai rametti di mirto, alloro, ulivo, palma, nonché agrumi e fiori, rappresentano un'offerta di ringraziamento a Dio per i prodotti della terra, un auspicio di buon raccolto, simbolo di ricchezza, benessere e prosperità, ornamento e opera d'arte, momento di riconoscimento comunitario, in cui si affermano valori umani e cristiani. L'altare, frutto di vera fede religiosa dedicata al Patriarca, rappresenta anche un vero capolavoro d'arte popolare. La struttura in legno dell'altare consiste in alcuni ripiani, di solito tre, a forma di gradinata, coperti da una tovaglia bianca e, come ornamento, il pane di frumento nelle forme e figure più disparate, che rappresentano dei simboli della tradizione cristiana. In cima agli scalini è posta un’immagine della “Sacra Famiglia”.
Le forme più comuni sono: la sfera, con la scritta J.H.S. (Jesus Hominum Salvator), la scala, la croce, la corona di spine e i chiodi, che rappresentano la passione di Cristo. “La serra e lu marteddu”, i ferri del mestiere del Patriarca; i cuori indicano l’amore fra i membri della Sacra Famiglia. Inoltre, ci sono le figure di colomba, aquila con due teste = stemma della Casa di Davide, pavone = resurrezione di Cristo, fiore, foglia, sacra famiglia, calice, stella, “Li cucciddati”, a forma di sole, simboleggiano la luce divina. Il melocotogno = amore, arancio = felicità, alloro = sapienza divina, fave= generosità, melograno = carità e resurrezione di Cristo, Il melograno aperto = Cristo che dona se stesso agli uomini, cavallo = intelligenza, cane = fedeltà, croce = salvezza, farfalle e uccelli = le cose non terrene, ecc.
"Li panuzza" sono dei panini in miniatura lavorati da fare invidia ai migliori ceramisti di Capodi¬monte. Per la preparazione delle pietanze, specialmente dei "panuzzi", occorrono decine di giorni di lavoro e vi partecipano tutti i vicini di casa. I doni posti sull’altare: pane, agrumi, fiori, rametti di mirto, d’alloro, d’ulivo e di palma, raffigurano offerte di ringraziamento a Dio, per i prodotti avuti dalla terra ed un auspicio di buon raccolto; sono anche simboli di ricchezza, benessere e prosperità, ornamento e opera d'arte allo stesso tempo.
Nell’altare si trovano spesso dei pesciolini rossi vivi in una vasca di vetro con l’acqua: rappresentano la vita.
Per la Sicilia di una volta, il grano rappresentava tutta la ricchezza di una famiglia; si lavorava un intero anno, per portare a casa la provvista alimentare per il prossimo anno, pertanto era l'alimento direi unico per sopravvivere. che, pertanto, si considerava come qualcosa di sacro. Mia madre ci rimproverava anche aspramente se noi ragazzi ne facevamo perdere qualche pezzetto; se ne cadeva un tozzo per terra si puliva, si baciava e si rimetteva a tavola. "Il pane è benedetto dal Signore e Lui si offende se lo trattiamo male" ci diceva.
C'erano contadini poveri senza lavoro "li iurnateri" che a volte si accontentavano di qualche chilo di pane per il lavoro di un’intera giornata. Il terremoto che avvenne a Castelvetrano la notte del 15 gennaio 1968 arrecò pochi danni alla chiesa a Lui dedicata, posta in Piazza Diodoro Siculo (ex Chianu di lu puzzu di li Sitti); ma, dopo alcuni mesi di transennamento, l’amministrazione comunale di allora pensò bene di demolire chiesa e convento annesso e così risparmiare i fastidi della ricostruzione.
In onore di San Giuseppe, mia madre, davanti al presepe di Natale, recitava “lu rusariu di San Giuseppi” e cantava “lu viaggiu di San Giuseppi” Dei due brani conservo le parole ed il motivo (che ho trascritto in musica). .In tutte le famiglie è rimasta la consuetudine di mangiare “lu tianu di San Giuseppi”.
Il condimento è preparato con le verdure di stagione, cucinate in tutte le maniere, più uva passa, pinoli, sarde fresche. In un tegame si dispone la pasta, il condimento e abbondante salsa di pomodoro; sopra si dispone uno strato di mollica e mandorle “atturratati” (abbrustoliti) e il tutto va a finire nel forno per la cottura finale.
Una volta questa pietanza si sistemava in un tegame di terracotta, si metteva sulla “furnacella” o sulla “tannura” con il carbone acceso e dell’altro carbone acceso si sistemava su un apposito coperchio, sempre di terracotta (focu sutta e focu supra); oppure si infornava nel forno a legna, immancabile in quasi tutte le case.
In occasione della ricorrenza di San Giuseppe, considerata in tutta l'Isola la prima festività della nuova stagione primaverile, oltre che la festa del papà, nelle famiglie continua la consuetudine di mangiare “li sfinci di San Giuseppi”.
Molti li preparano in casa, altri li comprano. Il nome sfincia deriva dal latino spongia, "spugna", ma può derivare dall’arabo. isfanc "spugna". Questi nomi hanno origine dalla particolare forma di questo dolce, che si presenta come una frittella morbida e dalla forma irregolare, proprio come una vera e propria spugna. L'origine di questo dolce è antichissima, tanto che compare, anche se con nomi diversi, nella Bibbia e nel Corano.
Inoltre, pare che sia l'evoluzione di pani o dolci Arabi o Persiani fritti nell'olio, ma col tempo questa gustosa e semplice frittella è stata trasformata in un dolce prelibato dall'abilità delle suore del monastero delle Stimmate, situato a Palermo, che l'hanno tramandato ai pasticcieri palermitani e l'hanno dedicato al Santo degli umili, come umili del resto sono anche gli ingredienti.
All'inizio la ricetta era piuttosto semplice ma, con il tempo, i pasticceri palermitani hanno reso questo dolce ancora più gustoso arricchendolo con alcuni ingredienti tipicamente siciliani: crema di ricotta, grani di pistacchio e canditi di scorza d'arancia. Secondo una vecchia tradizione, la sfincia veniva preparata dalla suocera per la nuora per cercare di "addolcire" i rapporti tra le due, tipicamente parecchio difficili e ostili a causa della gelosia delle due donne nei confronti, rispettivamente, del figlio e del marito.