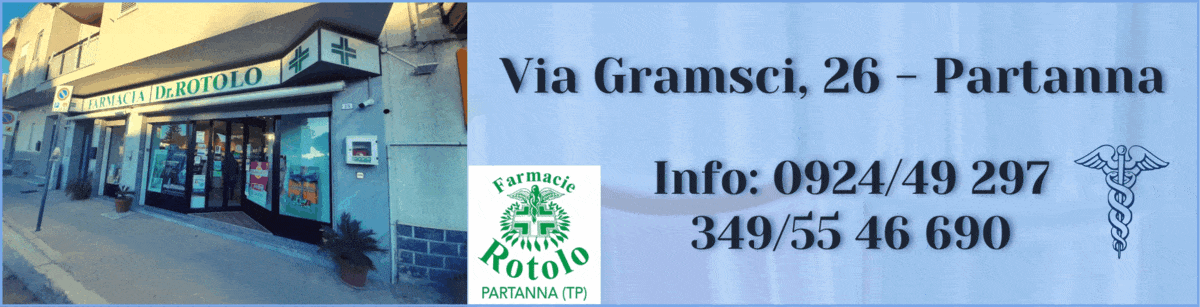Da la pasta “a scannaturi” ai fichi secchi e non solo. Quando la cucina era economica e fatta in casa
di:  Vito Marino - del 2018-07-08
Vito Marino - del 2018-07-08

In questo argomento voglio dare una mia testimonianza diretta non raccolta da varie ricerche su scritti effettuati da altri scrittori più o meno quotati. Incomincio con l’affermare che allora la vita giostrava sul noto proverbio: “Mangiare per vivere e non vivere per mangiare”, che poco si confà con la presente civiltà del benessere e del consumismo.

Dai miei lontani ricordi di ragazzo, gli anni ’45 – 50, con gli echi della II guerra mondiale ancora alle orecchie, quegli anni non sono stati certamente felici per chi non riusciva nemmeno a mangiare per vivere; infatti, il reddito fornito dal lavoro molto incerto, non garantiva neppure di saziare la fame. I benestanti, invece, vivevano solo per mangiare, poiché la vita anche per loro offriva pochi svaghi e divertimenti.
Ricordo che molte case delle periferie erano ancora diroccate dalle bombe. Si vedevano in giro molti poveri che chiedevano l’elemosina accontentandosi anche di un pezzo di pane duro. La salute lasciava molto a desiderare, allora c’era la malaria e la tubercolosi che mietevano vittime, ma anche la denutrizione faceva la sua parte.

Per le strade capitava spesso di incontrare persone con un arto amputato a causa di qualche granata esplosa durante la guerra, lasciandole per fortuna vive. Per la miseria qualcuno si ingegnava ad estrarre polvere da sparo da bombe inesplose, che ce n’erano moltissime, ma spesse volte ne restava vittima o invalida per tutta la vita. Malgrado questo degrado e questa miseria, si lottava disperatamente per sopravvivere; oggi invece i “figli del benessere” si uccidono quando un ostacolo si frappone sul corso della loro vita.
Ricordo che nell’aeroporto che abbiamo in contrada Fontanelle, esistevano ancora le carcasse degli aerei distrutti durante il conflitto. Molte strade non erano ancora asfaltate o erano dissestate e quando pioveva la fanghiglia le rendeva impraticabili. Inoltre, non esistendo allora la famosa statistica all’italiana, che livella il benessere indistintamente a tutte le persone, si diceva che le persone di questo mondo erano divise in due categorie: “Cu mancia e cu talia”.
In quegli anni Castelvetrano era priva di industrie, mentre gli artigiani, che erano molto numerosi, avevano poco reddito per il poco lavoro. Allora, solo la terra dava un reddito consistente per il suo proprietario. Purtroppo, a causa del latifondo ancora esteso, molti terreni restavano incolti poiché i ricchi proprietari di allora non avevano interessi a coltivarli, mentre il popolino, che direttamente o indirettamente dipendeva dall’agricoltura, viveva in condizioni economiche disagiate. Solo con le riforme agrarie degli anni ’60 avvenne un certo livellamento fra la classe contadina.
Quando “zappulìa la panza” (si sente il morso della fame), si cerca di riempirla in qualunque modo. Sorse così la cucina povera che oggi viene indicata il toccasana di varie malattie dismetaboliche provocate dal benessere.
Ricordo, che negli anni 50, certi ragazzi, per tamponare la fame, si arrangiavano a mangiare “panuzzi” (piccoli frutti di malva), “aira e duci” (acetosella) e le sue radici dolciastre, “pisci alasi” (detto scherzosamente era il cuore tenero del fusto dei cardi spinosi selvatici: cardo mariano) o succhiare il nettare di certi fiori come quelli dei gerani e di una pianta arbustiva selvatica molto comune dai fiori gialli oppure a raccogliere (rubacchiare) qualche frutto nelle campagne “di lu zzu Mattè” (lo zio Matteo); e si aggiungeva “quantu ci n’havi iddu ch n’haiu jè” (quanto ce n’ha lui ce ne ho io).
Era il tempo in cui “si liccava la sarda” per sopravvivere; un proverbio in merito diceva: “cu avi la sarda nun po aviri l’aliva”. Quando mia madre ci dava del formaggio come companatico, ci diceva scherzosamente: “a picca ch’è di pecura”, con lo scopo di farci capire che costava molto e bisognava risparmiarlo.
Parlando della classe operaia e contadina, allora si consideravano alimenti indispensabili, solo “panuzzu e pasticedda” (pane e pasta); chi riusciva a possederli si considerava fortunato e non si accorgeva d’essere povero; infatti, dietro c’erano i disoccupati, chi camminava a piedi scalzi, i numerosi invalidi di guerra ancora senza pensione, chi non riusciva a mettere la pentola perché non c’era pasta in casa, il contadino zappatore che andava a zappare accontentandosi di portare a casa soltanto qualche “vastedda” di pane.
Allora era normale fare colazione con pane accompagnato da arance, olive conservate (verdi, nere, schiacciate), fichi d’india, fichi secchi, mandorle; era pure normalissimo fare la cena con una “nzalata” di limone o d’arancia e pane raffermo (mai pane fresco, perché se ne consumava di più); la ricetta era semplicissima e non si poteva sbagliare: bastava mettere in un piatto un poco d’olio, un pizzico di sale, un bicchiere d’acqua e uno di detti frutti tagliati a pezzetti; un’altra pietanza per la cena era “l’ammogghiu d’agghia” fatta con pomodoro tagliato a pezzetti, aglio schiacciato, acqua, olio e sale. Visto che sono in argomento cito un’altra ricetta, di cui ho sentito parlare: “ncinagghia di monacu” (inguine di monaco): si preparano delle tagliatelle di pasta di casa e si condiscono con pomodori, aglio e prezzemolo, tutto tagliato molto fine.
Anche se allora i pesci costavano relativamente poco, c’era sempre qualche persona, che per risparmiare si faceva una minestra di pesce senza pesce: “la pasta a pisci fuiutu” (dal francese fuir = fuggire); la preparazione era uguale, ma... il pesce non c’era, perché era fuggito. La “pasta a la carrittera”, che con qualche variante diventa “pasta cu l’agghia”, era il piatto più comune per tutta l’estate. Un “mazzu di cicoria o di nirvia (indivia)” bollito serviva come condimento per la pasta e come secondo.
Con il pane raffermo grattugiato si preparavano polpette e “muddica atturrata” (mollica messa a riscaldare in padella con poco olio) che messa sulla pasta, sostituiva “lu saliatu” il formaggio grattugiato che costava. In sostituzione della proteina della carne, quando era possibile, si consumavano legumi, ma anche uova e latte.
Molto consumo si faceva di fico d’india, essendo allora un frutto molto comune e a basso costo; si consumavano sia quelli prodotti ad agosto “austini” che quelli scuzzulunati o bastarduna”. C’erano delle persone che se ne mangiavano anche un paniere per potere finalmente provare la sazietà, anche a rischio di “attuppari” (di subire dei blocchi intestinali). Infatti, i fichi d’india d’agosto si chiamavano scherzosamente anche “attuppaculu” In merito si diceva: “s’à moriri ha moriri saziu” (se debbo morire, debbo morire sazio); ma anche: “inchi la panza e jinchila di spini” (riempi la pancia e riempila di spine); in pratica si trattava sempre di una lotta per la fame e la sopravvivenza.
Ma al peggio non c’è mai fine, poiché c’erano delle persone ancora più povere che mangiavano pane e cipolla o pane e aglio o “pani e cuteddu” (pane solo). Quando ero bambino ho conosciuto un ragazzo “adduvatu” (che lavorava come garzone) per la trebbiatura del grano; una mattina a colazione mangiò del pane duro con una pala di fico d’india. Un’altra volta, un contadino ha accompagnato il pane con un filo d’asparago selvatico per avere un certo sapore in bocca. Qualcuno si mangiava anche la buccia d’arancia (allora non si usavano i pesticidi) col pane, mentre l’arancia sbucciata la mangiava dopo.
Altri alimenti, quando era possibile erano i fichi secchi, i pomodori secchi, olive in salamoia o schiacciate e “passuluna” (olive nere).
A quei tempi le persone “panza parata” (grasse compiacenti), guardate con una certa invidia dalla classe più povera della popolazione, erano pochissime. Fra il popolino era sconosciuta l’anoressia, l’obesità e la stitichezza; non c’erano bambini “spitignusi” (schizzinosi), che mangiano solo dietro promesse di regali e giocattoli, come avviene ai nostri giorni. L’uso del pane integrale, di molte verdure e legumi, cipolla e aglio era una nostra cultura, una necessità economica, una realtà storica a cui noi eravamo abituati (oggi si chiama cucina mediterranea, indicata come il toccasana per una lunga vita).
Sconosciute erano pure le palestre e le cure dimagranti; piuttosto si cercava di ingrassare, poiché la persona magra era considerata “cunsunta” (sospetta di essere ammalata di tubercolosi) e isolata da tutti, perché contagiosa. Allora i contadini, i manovali e in generale chi eseguiva lavori pesanti erano magri con la pelle del viso bruciata dal sole. Lo stesso avveniva per la donna della classe più povera della popolazione che, all’età di 40 anni circa già si presentava vecchia con i capelli bianchi, “sgangulata” (senza denti) e con la pancia dilatata per le continue gravidanze.
Di contro c’erano le persone benestanti, che avevano un buon tenore di vita. Essi erano i soli “panza parata” cioè col pancione, compiacenti del loro evidente benessere. Anche la donna della stessa famiglia era “scialacquata” per come si diceva allora, cioè messa bene in carne. Essi tenevano in casa numerosi animali da cortile, compresa la capra e il “ciaraveddu” (capretto); pertanto, carne, latte, uova ma anche i dolci non mancavano mai. Spesso essi tenevano “tavulata” (grande abbuffata) nella casa di campagna, invitando amici e parenti. C’era anche “la tavulata” per uomini soli: alcuni amici si trasferivano in campagna in casa di villeggiatura, per diversi giorni e si davano alla pazza gioia.
Ai giorni nostri, questo tenore di vita non fa più impressione, ma a quei tempi si.
Malgrado la povertà la dignità regnava anche fra i più poveri; la pulizia non lasciava a desiderare i lavoratori andavano a lavorare con i pantaloni rattoppati, ma puliti e stirati e mai stracciati. Essi cercavano di non sfigurare nella società (la gente, l’occhio di mondo) sostenendo delle spese non ammesse nel bilancio familiare, facendo poi economia nel mangiare; si soleva dire, infatti: “la panza ‘un avi finestra”.
Dolce, carne e frutta, allora, per problemi economici ma anche culturali, erano considerati alimenti voluttuari. La pasta “a la carrittera” con aglio e basilico, era molto usata anche dal ceto medio. I contadini, tasche permettendo, usavano spesso mangiare due volte al giorno pasta per reintegrare le energie consumate durante il loro duro lavoro (di lu scuru a lu scuru): anche 12 - 14 ore al giorno.
La pasta “a scannaturi” si usava in campagna durante la mietitura, la vendemmia e la raccolta delle olive: la pasta asciutta, appena cotta e condita, si versava in una madia e gli interessati, con la forchetta, o con le mani, facevano a gara a chi ne mangiava di più. Si mangiava bene nelle feste religiose e in quelle paesane o nelle ricorrenze familiari come matrimoni, battesimi, cresime. Si mangiava carne di maiale o di tacchino o di gallo cucinati a ragù con “sarsa sicca” (sugo di pomidoro preparato in casa), per Carnevale nei cinque giovedì antecedenti e nei tre giorni di vera festa: “li sdirri”.
Sotto l’incalzare dello sviluppo industriale del nord, l’arrivo delle ventate di modernità portate prima dagli americani dopo l’occupazione e dagli emigranti al loro rientro dalla Svizzera, dalla Germania e dal Belgio, tutto il sistema arcaico incominciò a crollare, le cicatrici della guerra scomparvero e la nuova generazione incominciò a cambiare decisamente il modo di pensare e di vivere.