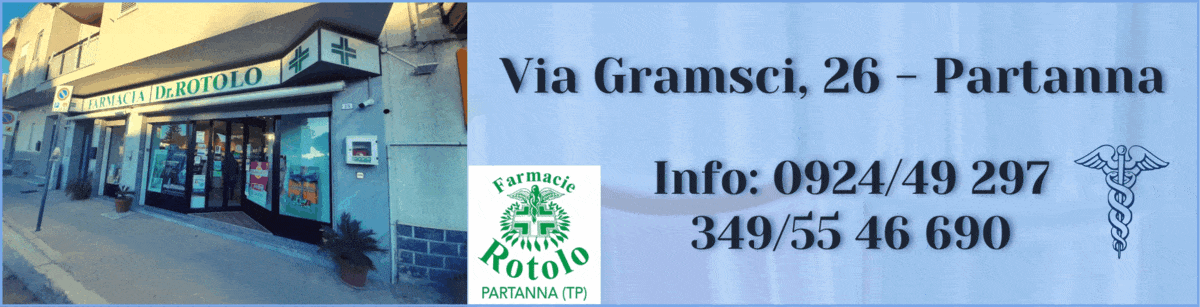"L'abbraciu" e il "furesi". Quando nel 1800 a CVetrano esistevano numerose fabbriche artigianali
di:  Vito Marino - del 2018-06-15
Vito Marino - del 2018-06-15

Nel 1800 a Castelvetrano esistevano numerose fabbriche artigianali in grado di produrre tutti gli articoli necessari per la vita quotidiana della gente del posto, compresi gli attrezzi di lavoro. Fra le altre c’erano fabbriche artigianali di tele diverse, come canapa, seta e albagio.

La tessitura veniva effettuata in casa, con telai manuali, dalle donne (un evento eccezionale per la civiltà maschilista di allora). In un lontano passato, in Sicilia, tutti i vestiti dei contadini, compresi i cappotti e le mantelle erano confezionati con l'albagio, un tessuto speciale di lana rustico, che in dialetto chiamavano “abbraciu”.
Questo tessuto serviva anche per confezionare “vrazzali e pitturali” a protezione delle braccia e del petto per non pungersi con le reste del grano durante la mietitura a mano. L’albagio, oggi in disuso ha origine molto antica, probabilmente era già usato per il vestiario dei soldati dell'antica Roma.

Questo tessuto si presentava rustico e pungente; per renderlo più morbido aveva bisogno di un’apposita lavorazione, come la battitura con una mazza mossa dalla ruota del mulino ad acqua o mulino idraulico dei vecchi tempi, un impianto destinato ad utilizzare l'energia meccanica prodotta dalla corrente di un corso d'acqua, tramite opportuna canalizzazione; quindi i tessuti passavano in calderoni con aggiunta di argille e materiali sgrassanti, e bolliti, a tale scopo c’erano due gualchiere dette anche folloni o paratori.
L’origine del nome albagio deriva dall’arabo “al-bazz”, che significa stoffa, tela. Di albagio erano i tessuti usati per la confezione dei sai dei monaci medioevali. In epoche recenti si è diffuso l'uso di altri tessuti di più facile confezione, mentre l'albagio è rimasto in uso soltanto in alcune zone rurali (di albagio, per esempio, è il costume tipico dei contadini di Modica, provincia di Ragusa).
Ma, questo tipo di tessuto era molto usato anche in Sardegna, paese in prevalenza di pastori, dove l’utilizzo della lana è antichissimo; dalla sua filatura si otteneva un tessuto povero di lana grezza, ruvida e un po’ pungente, chiamato in sardo: “furési” o “orbace”, molto usato per confezionare artigianalmente indumenti e articoli vari. Interi villaggi erano dediti alla produzione di questo tessuto (per esempio Arbus, nella provincia del Sud Sardegna o Tiana (Nuoro).
Qui la lavorazione dell’albagio è continuata più a lungo, come tradizione, soltanto nei paesi montani, nei quali si è in generale mantenuta maggiormente l’uso del costume tradizionale sardo. In Sardegna la lana delle pecore viene dapprima immersa per alcune ore in acqua riscaldata fino a 50°, in modo da non privarla del tutto dei grassi naturali che contribuiscono a conferire al tessuto una certa impermeabilità; essa è quindi lavata nelle acque dei torrenti, onde asportarne definitivamente le materie estranee.
Dopo essere stata asciugata al sole la lana viene poi “laminada” (cardata) e pettinata con pettine a chiodi, quindi, prima di procedere alla filatura, si selezionano i peli di lana più lunghi e resistenti da destinare all’ordito, mentre la rimanente è lasciata per la trama.
La filatura veniva effettuata manualmente con la conocchia e col fuso dalle stesse donne dei pastori. La tessitura avveniva con telai a mano rudimentali.
Siccome Il tessuto, che esce dal telaio, è molto ruvido e rigido, anticamente si praticava il processo di follatura, che consisteva nella battitura del tessuto imbevuto di acqua calda insaponata, che veniva tradizionalmente effettuata calpestando a piedi nudi i tessuti allo scopo di far compenetrare tra loro le fibre e ottenere un tessuto compatto che ne provoca l'infeltrimento, in modo da ottenere un panno robusto ed impermeabile.
Il tessuto viene lasciato in riposo per alcuni giorni e poi si procede alla tintura. Il “furèsi” (l’albagio) così ottenuto costituiva il tessuto più usato per il costume tradizionale sardo maschile; con esso si preparavano: Giacche e pantaloni pesanti, “sa berritta” (pesante berrettone di lana, a forma di sacco, di colore nero, che si lasciava cadere sull’omero, dietro le spalle o lo si ripiegava sulla fronte, come una lunga visiera copricapo a forma di sacco), “is ragas” (il gonnellino nero di asciutti contadini e pantaloni bianchi), i "gabbani" (specie di cappotti con cappuccio cappotti lunghi fino ai calcagni spaccati dietro per permettere di cavalcare), la “gabbanella”, la parte del costume più diffusa, piccolo cappotto che si portava d’estate e d’inverno per proteggersi tanto dal caldo come dal freddo, di colore nero, i corpetti dei costumi tradizionali, il cappuccio fratesco, i “borzachinos”, alti calzari neri, chiusi od anche aperti verso l’interno ed allacciati al polpaccio, che difendano il contadino ed il pastore dalle intemperie e dall’aggressione dell’ambiente, “su saccu de coberri” (sacco per coprire) composto da due teli di stoffa neri cuciti uno sull’altro e uniti da un lato; utilissimo capo di vestiario tipico dei pastori, utilizzato in maniera intensiva nella loro esistenza randagia, per ripararsi dalla pioggia e dal freddo, da cappotto, da stuoia, come coperta da letto, tappeto, cappuccio, in ogni stagione, sempre e ovunque.
L’orbace era meno presente nell’abbigliamento femminile in cui era utilizzato soprattutto per il confezionamento delle gonne nei costumi di alcuni paesi nei colori rosso e marrone meno cupi e più vivaci. Inoltre si fabbricavano “sas bértulas” (dal latino bertula, cioè bisaccia), coperte, giacconi, maglioni e lenzuola che proteggevano da freddo o intemperie.
Durante il fascismo, all'epoca dell'autarchia, venne incrementato l'uso dell'orbace al posto dei tessuti tradizionali. Vi fu una vera e propria "campagna dell'orbace", che ebbe riflessi positivi sull'economia rurale della Sardegna. Di orbace erano infatti le uniformi della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (le cosiddette "camicie nere") e delle organizzazioni giovanili del regime.