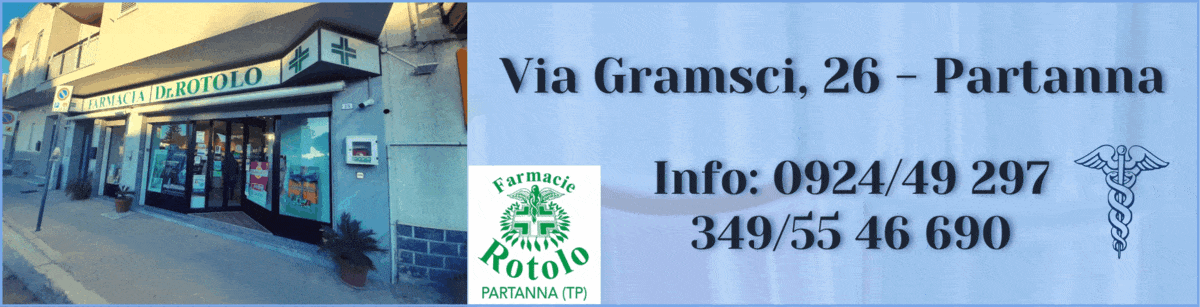Quando portare la moglie all'Aurora era un obbligo matrimoniale. Storia di un rito intramontabile
di: Francesco Saverio Calcara - del 2015-04-01

(ph. Foto Ino Mangiaracina)
Sono un inguaribile tradizionalista, attaccato, come tanti, a usi e costumi (come suol dirsi) della mia terra. Mi piace, ancora come tanti, partecipare alle manifestazioni popolari della Settimana Santa, che da noi in Sicilia – forse per quella voluttà della morte di cui parla Tomasi di Lampedusa – raggiungono punte di pathos che hanno eguali solo nella (ex) cattolicissima Spagna. Non mancavo di andare ai Misteri di Trapani, prima che uno stupido divieto vescovile togliesse con gli incappucciati gran parte del fascino a quella processione.

Così come non manco mai all’Aurora di Castelvetrano, perché mi attira l’idea di assistere a gesti si ripetono sostanzialmente immutati da centinaia d’anni, segno di una continuità, di una identità di popolo che, su altri versanti abbiamo purtroppo irrimediabilmente perso, omologati e risucchiati negli standard del villaggio globale. E’ strano infatti che il siciliano, così diffidente e individualista, si apra poi a forme di religiosità, forse primitive, ma certamente aggreganti.
La suggestione, dicevo; forse la risposta è in questa parola. Cerchiamo un rapporto col sacro fatto di fuggevoli impressioni piuttosto che di autentica conversione; preferiamo rapportarci a statue di cartapesta sulle quali dipingiamo il dolore universale (Cristo morto, l’Addolorata) o la vittoria della vita (ecco le varie Giunte, Aurore, Paci che si celebrano un po’ dovunque), che resta, tuttavia, al livello di sacra rappresentazione, alla pirandelliana dimensione dell’eterno teatro; di qualcosa che è bello a vedersi o a farsi, ma che dopo, quando torniamo a casa, non ci riguarda più.

Ma non voglio avventurarmi in analisi sociologiche né – Dio me ne guardi – propugnare l’abolizione o la trasformazione delle tradizioni religiose concernenti la Settimana Santa. Vorrei solo riflettere sulla necessità di superare appunto la suggestione, verso la radicale e coinvolgente assunzione di responsabilità che deriva dalla fede nella morte e resurrezione di un uomo che disse di essere Dio.
Si tratta di fare davvero Pasqua, di “passare” cioè da un fideismo accomodante alla trasformazione interiore che capovolge tutto il sistema di valori basato sulla logica del successo e dell’apparire. Ma per arrivare a questo, non me ne voglia il vescovo (emerito) Micciché, non serve far togliere un cappuccio o accorciare una “annacata”, sentiamo la necessità di testimoni coerenti, di annunciatori fedeli della Parola.
Molti preti hanno creduto che bastasse alla loro missione il fatto di apparire aggiornati, di “piacere”, di essere simpatici, mentre ciò di cui gli uomini (e i giovani, soprattutto) hanno bisogno è di sentire qualcuno che proclami loro la Verità, anche se scomoda e difficile.
Di questo abbiamo bisogno in particolare noi Siciliani, così bravi nel rabberciare, nel mediare, nel giustificare; così insuperabili nell’arte del compromesso; così ostinatamente presuntuosi nel pensare di essere sempre i migliori perché abbiamo capito tutto, e così tragicamente “isole”. “Sia il vostro parlare sì, sì; no, no. Tutto il resto viene dal maligno”: è questo che dobbiamo imparare.
Per tornare alle cose nostre, i riti della settimana santa hanno costituito, da sempre, occasione di pubbliche celebrazioni di pietà nel popolo castelvetranese. Se la processione del venerdì santo accomuna Castelvetrano a tanti altri centri siciliani, la funzione dell’Aurora che si tiene la mattina di Pasqua, costituisce uno specifico e quasi una sorta di prerogativa della nostra città, anche se, per la verità, in molti altri centri della Sicilia si celebra l’incontro fra il Cristo risorto e la Vergine Maria.
Ma la nostra particolarità, oltre nel nome di Aurora - che di là dal connotare l’ora mattutina in cui si svolge, ha un evidente significato propiziatorio relativo al senso cristiano della Pasqua -, consiste anche nel ruolo di messaggero ricoperto qui da un angelo, e al volo di colombe che al momento dell’incontro, liberate da un meccanismo che fa scivolare il mantello nero di Maria, si scioglie nel cielo primaverile.
La sacra rappresentazione, che si inserisce nel quadro di quella spettacolarizzazione liturgica tipica dei paesi che gravitavano nell’orbita della Spagna, fu introdotta a Castelvetrano, verso il 1660, dai padri Carmelitani scalzi di santa Teresa, il cui convento, oggi distrutto, era annesso, alla chiesa di san Giuseppe.
La confraternita dei falegnami e bottai curava l’addobbo e il trasporto del simulacro del Cristo risorto, mentre quella del Rosario si occupava della Vergine Maria. Scomparsa la compagnia del Rosario, è la confraternita di san Giuseppe, ancora esistente, a curare l’annuale appuntamento dell’ Aurora, ricorrenza di cui Castelvetrano è tanto gelosa da far nascere, non si sa bene su quale base, la convinzione che se l’ Aurora non si fa “si la pigghia Trapani”.
Circostanza che, almeno una volta, fu seriamente temuta, nella Pasqua del 1717, allorquando, come narra il Ferrigno, per l’accidentale mancato rispetto della prerogativa della chiesa Matrice di dare i tocchi della Resurrezione, il burbero arciprete Giglio lanciò l’interdetto alla chiesa conventuale di S. Giuseppe. Il rischio che non si tenesse l’Aurora fu comunque evitato grazie al provvidenziale intervento di mons. Bartolomeo Castelli, vescovo di Mazara, che in extrtemis ne autorizzò lo svolgimento.
Nei tempi passati si costumava sancire addirittura nei contratti matrimoniali l’obbligo dello sposo di condurre la propria moglie alla festa dell’ Aurora e alla fiera della Tagliata. I più anziani ricordano la lunga teoria di carretti che sin dalla notte del sabato venivano dalla vicina Campobello a prendere posto per la festa dell’ indomani.
Festa pagana, dice qualcuno; trasposizione in chiave religiosa di antichi riti primaverili legati al ciclo agricolo, pontifica qualcun altro; cosicché in passato anche qualche pretino, animato da falso spirito di rinnovamento e da uno zelo degno di miglior causa, ne aveva cautamente proposto l’abolizione.
A me sembra, invece, che il rito vada invece conservato e valorizzato quale espressione della simbologia della vittoria della vita sulla morte; e ciò mi sembra importante, di là dal valore religioso che pure è importante, anche come fattore di riscatto da un’idea tanto sedimentata nell’anima del nostro popolo.
Fra tutti, come dicevo prima, il pensiero della morte e di ciò che la segue ha da sempre attraversato la fantasia della nostra gente.
Non a caso, uno dei più grandi scrittori siciliani, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ha individuato nel motivo della morte il protagonista implicito del Gattopardo: “Tutte le manifestazioni siciliane sono manifestazioni oniriche, anche le più violente: la nostra sensualità è desiderio di oblio, le schioppettate e le coltellate nostre, desiderio di morte; desiderio di immobilità voluttuosa, cioè ancora di morte…”.
Il fascino oscuro della morte e dell’aldilà è largamente attestato in Sicilia dalle fonti e dal mito. Il passaggio dalla sfera mitica al rito si applica in modo esemplare proprio nell’Isola, quando si parla di Demetra e Kore, le due divinità note per i misteri eleusini.
La vena ispiratrice di questo mito è legata all’attività agraria e alla fecondità; l’agricoltura e i suoi simboli, il grano, la spiga, sono il sostrato di base da cui si sviluppa tutta la vicenda, per culminare nel rapimento della figlia, e si traduce nell’avvicendarsi del ciclo stagionale di nascita-morte-rinascita.
A questo si affianca il rituale del rapimento, della discesa agli inferi, della theogamia con Ade, della ricerca da parte della madre, del ritorno di Kore sulla terra. La stessa presenza del santuario di Malophoros a Selinunte è la testimonianza più prossima di quanto il culto dell’oltretomba sia radicato nella memoria collettiva del nostro popolo. Intesi a procurare la felicità oltre la tomba,
i misteri rivelavano probabilmente la via che l'anima era obbligata a seguire dopo la morte: "Felice è chi ha ricevuto tale visione prima di scendere sotto terra; - esclama Pindaro - egli conosce cosa sia la fine della vita; ne conosce il principio donato da Zeus".
Né è estranea al deposito di tale struttura mentale la fortuna in Sicilia, durante la dominazione araba, di un testo che si vuole sia stato fra i modelli della Commedia di Dante: il Libro della Scala di Maometto, nel quale si sviluppa il concetto di ascesa dell’anima individuale nei regni ultraterreni, come allegoria della purificazione graduale dell’uomo; un elemento, questo, che fin dal secolo VIII costituisce il motivo di fondo di numerosi racconti mistici ispirati al miraj di Maometto.
E non è fortuito che a uno di questi racconti si ispiri un’opera cristiana, redatta in Sicilia alla fine del sec. XII e resa nota da M. T. D’Alverny in Les pérégrinations de l’âme dans l’autre monde (1940-42), nella quale l’anonimo redattore, che aveva molta familiarità con la filosofia neo-platonica e con i commenti avicenniani ad Aristotele, prospetta, dopo la morte, un’ascensione dell’anima al Paradiso e una sua discesa all’Inferno.
E come non ripensare al fatto che in Sicilia sono proprio i defunti a recare i doni ai fanciulli, segno di una ideale continuità generazionale, del radicato convincimento di una qualche forma di vita oltre la morte? o il perdurare, appunto, delle sacre rappresentazioni pasquali, retaggio della lunga influenza spagnola, nelle quali il dramma della passione di Cristo e dell’angoscia della Madre sono vissuti - in quella che Sciascia definisce, forse troppo frettolosamente, una visione materialistica della religiosità - come la proiezione del dolore universale, vissuto però nella prospettiva catartica e liberatoria della Resurrezione; laddove la gioia della vittoria della vita sulla morte, della luce sulle tenebre – Aurora, appunto! - si esprime sovente in toni che possono apparire, a chi non conosce sino in fondo l’animo del popolo siciliano, esagerati e quasi pagani? Mi sovviene a proposito quanto scrisse Jean Houel nel suo Viaggio in Sicilia, compiuto tra il 1776 e il 1780, allorché, assistendo proprio a Castelvetrano ad una processione religiosa, annotava che la sacra cerimonia si presentava più pittoresca che edificante, e aggiungeva: “La natura di questo popolo si rivela nelle feste.
E spesso se non fossero trattenuti dal decoro che la religione comporta ed esige, gli impulsi di un santo zelo li porterebbero a stravaganze non meno strane che ridicole”.
Quel viaggiatore di Rouen aveva capito ben poco della Sicilia e dei Siciliani. Per dirla con Giuseppe Cocchiara, “il siciliano (…) sarà siculo-sicano, greco, arabo, normanno o quel che volete. Egli tuttavia è tutto ciò e nulla di tutto ciò.
Era greco, e in Lui la nostalgia sicano-sicula agiva come forza assimilata. Era arabo, e in Lui rimanevano i caratteri migliori della Grecità. Era normanno, e in Lui agivano i ricordi di tutte le dominazioni del passato.
Le conquiste, le distruzioni e le spoliazioni non lo avviliscono: sono come la lava dell’Etna. Sotto la lava cresce la ginestra e la lava diventa di nuovo terreno; la stessa cosa accade al siciliano: come quell’arido terreno rinasce a nuova vita. E se i re hanno lasciato la loro storia nei palazzi e nel diritto, i popolani l’hanno segnata nella leggenda, nei culti, nei canti”.
Questa, dunque, la vera anima del popolo siciliano. E a coloro che storcono il naso, ritenendosi “cristiani adulti” ribadisco di saper bene che non sono le manifestazioni esterne a misurare di per sé l’autenticità del sentimento religioso; ma so anche che “lo spirito soffia dove vuole” e non comprendo pertanto certe “uscite” iconoclastiche.
Sia come sia, piaccia o meno, quel rito di Resurrezione costituisce un appuntamento in cui la comunità ritrova e rinsalda i vincoli della sua memoria storica, il senso della sua identità, della sua religiosità e della sua dignità di popolo. Valori di cui, oggi come non mai, Castelvetrano ha bisogno, e dunque: viva l’Aurora!