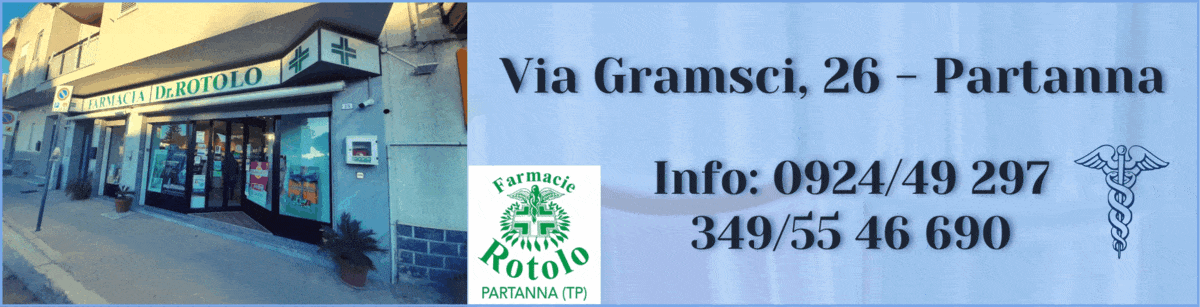I quattro “conzi” e la semina in base al calendario tra credenze e superstizione. Come avveniva la lavorazione del grano
di:  Vito Marino - del 2018-03-04
Vito Marino - del 2018-03-04

Oggi molti giovani sanno soltanto che il pane si compra dal panettiere e la pasta al supermercato, pochi conoscono la materia prima usata e tutti i lavori necessari per produrla.

Anche se non c’erano più i grandi feudi coltivati a grano, come avveniva nel 1800, negli anni ‘46-51, del 1900, quando frequentavo la scuola elementare, l’agricoltura era tenuta ancora in grande considerazione; i temi da svolgere si riferivano spesso ai lavori dei campi ed in modo particolare alla coltivazione del grano ed alla mietitura.
Attraverso i miei ricordi d'infanzia e da quanto ho appreso da vecchi contadini (fonte inesauribile di notizie sulla scomparsa civiltà contadina), cercherò ora di descrivere i lavori una volta necessari per la coltivazione e la raccolta dei cereali.

Credo che, per i particolari riportati, l’argomento sarà un poco noioso, anche se interessantissimo.
Per i contadini dell’Ottocento il vero sacrificio era quello della pianticella di grano, nella cui vicenda era addirittura raffigurata la passione e morte di Gesù Cristo. i guai che passava l’umile pianticella: veniva falciata, trasportata nell’aia come il Salvatore sul Golgota; e qui battuta, calpestata, maciullata fino a dover declinare il capo come un giglio secco; e tutto questo per nutrire l’uomo sotto forma di pane. Si comprende allora perché i contadini mettessero ogni fase del ciclo del grano e la stessa panificazione sotto la protezione di Dio, della Madonna e dei Santi, senza preoccuparsi di apparire ridicoli agli occhi degli altri.
I metodi di coltivazione erano fin troppo arretrati, «presso a poco gli stessi di quelli che si avevano ai tempi di Virgilio e di Calumella, vigendo, quasi ovunque, il sistema triennale con maggese, non solo nei grandi fondi, ma anche nelle piccole tenute, e nulla facendo per eccitare la naturale produttività del suolo».
Il contadino accorto cominciava a seminare il giorno di Ognissanti, in ottemperanza al detto: la prima a Tuttisanti, l’ultima a Sant’Antria. E finiva entro il 30 novembre, giorno consacrato appunto a Sant’Andrea. Nessuno però aspettava oltre l’11 novembre per iniziare, perché pri San Martinu megghiu sutta terra lu frumentu chi a lu mulinu.
Né terminava dopo la festa di Sant’Antonio Abate (17 gennaio). Sinu a Sant’Antoni, li simenzi su boni, si diceva infatti a Mazara. Dopo era consigliabile aspettare il mese di marzo per seminare tumminia, le cui rese erano di solito inferiori a quelle di qualsiasi altro tipo di frumento.
Generalmente per dare il tempo al terreno di reintegrarsi dell’azoto ceduto al grano della precedente annata agraria, si usava la rotazione agraria, alternando la coltivazione del frumento con legumi, erba medica o pascolo; quindi si coltivava il grano ogni tre o quattro anni. I concimi chimici comparsi agli inizi del 1900 da noi incominciarono ad usarsi più comunemente intorno al 1970. In mancanza di concime una volta per dare il tempo al terreno di reintegrarsi d’azoto, si usava la rotazione agraria, alternando la coltivazione del frumento con legumi, erba medica o pascolo.
A fine ottobre iniziava l’aratura dei campi. Si praticavano preliminarmente due solchi lungo i confini “finaita”, quindi, partendo da un angolo, si dava il primo colpo di vomere in senso diagonale (tripla) e si proseguiva a solchi paralleli. Per una giusta lavorazione del terreno, alle prime piogge si procedeva a una seconda aratura (rifunniri), questa volta “a rumpiri” (perpendicolarmente alla prima aratura). Il grano da semina già selezionato in casa dalle donne, si disinfettava col “silestru (solfato di rame) contro eventuali malattie da funghi, come il “mascareddu” (male della volpe), che attacca la spiga riducendola in polvere.
La semina poteva avvenire a “spagghiu (o a pruvinu)” o a “sulicu”: Nel primo caso il seminatore prendeva con la mano destra il grano dalla “coffa tumminara”, a forma tronco conica, legata con una cinghia al manico interno e alla spalla sinistra, mentre con la mano sinistra teneva aperta la coffa tramite l’altro manico, lanciandolo.
Nella semina a “sulicu” i semi si introducevano in un imbuto provvisto di una lunga cannella che faceva cadere il grano direttamente nel solco. In ogni caso, dopo la semina si passava l’ erpice per coprire i solchi e interrare i semi. A marzo l’interfilare si zappava per togliere le erbe. Nel terreno seminato “a spagghiu”, con la zappetta si toglievano soltanto “l’anitru” (la ridolfia), “il tren” (melitolo) e il “giogghiu” (il loglio) velenoso.
L’aratro di legno, con un solo vomere detto a chiovu, che si voleva inventato da Cerere e da Trittolemo, a trazione animale era composto da una lunga pertica e tirato tramite il giogo “lu juvu” da due buoi o muli; poteva trascinare un vomere più grosso e veniva chiamato "l’arati a dui" o “lu tiru a dui” (aratro doppio), era usato da millenni dai contadini. In tempi più recenti, verso il 1930 è sorto “lu mezz’arati o arati a forficia o a scocca”, (aratro semplice) con due aste fra le quali si “mpaiava” (legava) un solo mulo. Nello stesso periodo è sorto l’aratro di ferro.
Questo genere di aratro cessò di esistere come attrezzo di lavoro, quasi a taglio netto nel 1950, quando entrarono in funzione i trattori meccanici. Esemplari di quest’arcaico strumento aratorio sono esposti nei musei etno-antropologici di tutta la Sicilia ed é possibile persino incontrarne qualcuno in funzione in alcune plaghe dei Nebrodi e dell’Etna. «Esso — sono parole di un agronomo di un secolo fa — consta del ceppo forato in centro e a cui s’innesta la bure, ad angolo ottuso, lunga da m. 3,80 a 4.
Alla parte superiore del ceppo si ha la stiva (manuzza), nella parte inferiore il dentale a cui s’innesta il vomere, che consiste in una punta di ferro di forma lanceolato—acuta. Il ceppo viene connesso alla bure mercè un’assicella di olivastro o in ferro (tinagghia) la quale è fissa sul ceppo e scorrevole per la parte superiore entro un foro praticato nella bure; allargando o restringendo l’angolo che la bure forma col ceppo, si viene ad avere un lavoro più o meno profondo.
L’aratro così costituito viene ad esser legato al giogo (poggiato sul dorso nel caso del tiro equino, sul collo nel caso del tiro bovino) che consiste in un pezzo di legno lungo almeno m. 1,60 portante alle estremità un anello di ferro e al centro un archetto ove s’introduce la punta della bure; finalmente fa ancora parte del tiro la rulla (augghiata), lungo bastone munito per un’estremità di una paletta in ferro.
Con simile strumento, privo di coltello e di orecchie, oltre ad avere un maggior consumo di forza non si raggiunge che un semplice spostamento del suolo; con esso si aprono gran numero di solchi l’uno accanto all’altro, e spesso rimane fra due solchi una striscia di terra punto scossa per cui la preparazione fisica sarà niente uniforme».
Dietro l’aratro, a piedi, veniva il contadino, per dirigere l'animale e tenere l'aratro nella giusta posizione e direzione. Pr dirigere l’animale da tiro, c’erano le retini legate alla cavezza “li crapisti” del mulo oppure al nasiere (posto alle narici) dei buoi. Quando per tirare l’aratro il contadino si avvaleva del bue, doveva “firrari” gli zoccoli con i “mezzi ferri”, perché il bue ha lo zoccolo del piede più piccolo di quello degli equini.
In questi casi l’animale era chiamato “Lu voi a lavuri” (preparato per lavorare con l’aratro). “Lu lavuraturi” (chi arava) impiegava diverse giornate di questo duro lavoro, per “mettiri ‘n conza la terra” (preparare il terreno alla semina), spesso con le scarpe pesanti a causa della terra umida attaccata alla suola.
Dopo, si procedeva alla semina. “Lu siminzeri” (chi spargeva le sementi), con “la coffa tumminara” messa a tracolla, spargeva i semi “a sulicu” (lungo i solchi lasciati dall’aratro) o “a spruvulu o a spagghiu” (spargendo il grano con un largo gesto della mano); dopo, provvedeva a spianare il terreno per coprire le sementi. Quando la semina si effettuava a “spagghiu” le erbacce che crescevano si potevano estirpare a mano o con una zappetta stretta.
Quando si seminava a “sulicu” la semina si effettuava lasciando un solco vuoto, dopo quello seminato oppure tre solchi seminati e tre vuoti. In questi spazi si poteva zappare per rendere il terreno più soffice e per togliere le erbacce. Addirittura quando lo spazio lasciato era maggiore si poteva passare con l’aratro. Qualcuno aveva inventato anche un aratro con quattro vomeri piccolini.
Per consuetudine, ma anche perché considerato un mese propizio - augurale, la semina iniziava per “tutti li santi”, cioè il primo novembre. In quella data si presume che già ci siano state le prime piogge e il terreno è “’n conza” (abbastanza morbido per ricevere il vomere dell’aratro). Per Sant’Andrea, cioè il 30 novembre era l’ultimo giorno propiziatorio. In questo periodo rientrava l’Estate di San Martino, intorno all’11 novembre, con le sue giornate splendide, che permettono qualsiasi lavoro nei campi. Fino a Sant’Antonio (17 gennaio) si possono seminare terre buone e cattive, dopo Sant’Antonio solo le terre buone. Infatti un proverbio diceva “Pi Sant’Antoni / tinti e boni, / doppu Sant’Antoni sulu i boni”.
Spesse volte, per mancanza di pioggia o per pioggia eccessiva, si doveva rinviare la semina fino a marzo. Poiché si era già in ritardo, si seminava “la tumminia” un tipo di frumento che riusciva a recuperare il tempo vegetativo perduto, permettendo la regolare mietitura a giugno.
Il periodo dell’anno adatto per la semina era l’estate di San Martino, una settimana di buon tempo che ogni anno si ripete intorno all’11 novembre. Se per mancanza di tempo od intemperie non era possibile la semina durante tutto l’inverno, a marzo c’era ancora la possibilità di seminare la “tumminia”, un frumento che riesce in poco tempo a recuperare il tempo vegetativo perso. Ma il terreno, secondo il Pitré aveva bisogno di essere preparato nel corso dell’anno, con quattro “conzi” (arature). A marzo si arava per la prima volta “si ciacca”; a maggio o giugno si arava per la seconda volta “si dubra”, facendo i solchi in linea opposta a quelli di prima; ad agosto si “rintrizza” (si ara per la terza volta); finalmente, a seconda delle condizioni atmosferiche si ara per la semina.
Da ricerche fatte fra i contadini mi risulta che i tipi di “furmentu” (frumento) coltivati nelle nostre zone erano: “Russulidda”, che fa lespighe e le reste rossiccie, bianculidda, bilì, saracinu, zizzìa. e tumminìa”. In altre zone del catanese e siracusano le cultivar erano: “Maiorca, o mjorca (Triticum vulgare) è un tipo di grano tenero antico a chicco bianco a maturazione veloce, da secoli coltivato in Sicilia soprattutto in terreni aridi e marginali, da sempre è stato considerato come il sinonimo del grano tenero siciliano e la sua farina sinonimo di farina per dolci. l’unico gracno tenero siciliano, che ha le spighe con le reste corte, maiorca pilusa o sganguni, ruscia o furmentu biancu, furmentu forti o piluseddu (triticum durun = grano duro), gurria, o furmentu di la Maronna, urbia ‘mpiriali, furmentu di Franza o francisedda, giustalisu giganti, percia sacchi e tumminia”. I semi erano stati scelti uno per uno dalle donne in casa dopo la mietitura, la “cacciàta” del frumento, la lavatura e asciugatura al sole, eliminando quello difettoso, piccolo o bucato dal “munaceddu”. Questa operazione si chiamava “assiddirii lu furmentu”.
Dopo la semina occorreva ora mandare via gli uccelli, perché avrebbero beccato una parte delle sementi; tale compito era affidato alla numerosa prole, che, percuotendo delle lattine, li spaventava e non li faceva posare per terra. Qualcuno metteva gli spaventapasseri con dei fantocci a somiglianza d’uomo. Dopo la nascita delle piantine, bisognava estirpare le erbacce con le mani e zappettare con "lu zzappuneddu” (la zappetta stretta) negli interfilari, per rendere soffice il terreno.