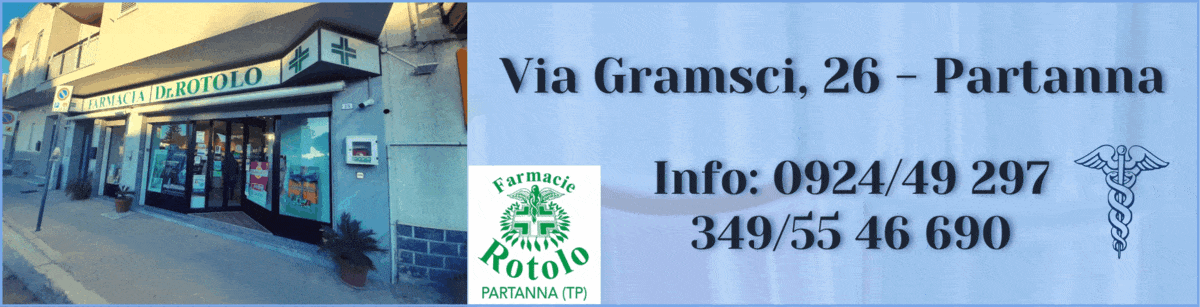"Lu pani di casa" tra ritualità, tradizione e aneddoti nel ricordo dei tempi che furono
di: Giacomo Mendolia - del 2018-03-15

Non di rado mi capitava di restare a dormire dai miei nonni e per me era sempre una festa specialmente quando, già la sera, durante la cena, mia nonna Maria programmava con mia zia Grazia, ancora non sposata, di fare il pane in casa.

Io ero raggiante perché già sapevo che, oltre al pane, quel giorno, si sarebbe fatto qualche altro manicaretto: l’arianata o la brucculata, una sorta di calzone con dentro dei cavolfiori sbollentati, fritti e conditi con tanto pepe.
La sveglia per loro suonava molto presto, all’alba. Io, rannicchiato nelle coperte di lana, sostavo ancora un po’, ma non tanto, perché non volevo perdermi quel rituale fatto di gesti stereotipati, arcaici e arcani allo stesso tempo.

Mia nonna, dopo aver fissato i capelli con un cerchietto metteva un copricapo, il classico “fazzulettu a mirriuni” per igiene; poi indossava un grembiule bianco, pesante, un po’ rigido al tatto, fatto di una stoffa grezza, di cui non saprei dire il nome.
In cucina era già tutto pronto: la quadara (pentola) con l’acqua che bolliva faceva leggermente sollevare il coperchio quasi a voler avvisare, “lu scannaturi” cioè lo spianatoio in legno posto su dei trampoli in ferro (trispa) e un bel fascio di legna di olivo già piazzato quasi davanti al forno.
Mia nonna, coadiuvata da mia zia, prendeva la farina conservata in dei sacchi di stoffa bianca posti in una stanza molto grande, cieca, attigua alla cucina, una sorta di dispensa dove c’era di tutto: la giara con l’olio, quella in terracotta in cui si conservavano le olive in salamoia, i contenitori in vetro contenenti la “sarsa sicca”, quelli con la marmellata di mele cotogne e quelli con i fichi secchi preparati durante l’estate a Cerarsa “’nchiappati” e messi uno sull’altro con l’aggiunta di foglie d’alloro per aromatizzare. E in un angolo un lettino pronto per mettere “lu pani a lettu” cioè ad attendere che lievitasse, usato solo per quello.
La farina veniva posta all’interno “di lu crivu di sita”, una sorta di filtro, per togliere eventuali impurità o tracce di crusca. Con ampi movimenti circolari e agitando energicamente, la farina cascava giù sullo spianatoio, impalpabile, come fosse neve, fino a creare una sorta di monticello. Poi al centro si allargava trasformando il monticello in una sorta di vulcanello e lì dentro si scioglieva “lu criscenti”, il lievito naturale di una volta, ottenuto con una pagnotta conservata l’ultima volta che si era fatto il pane in una terrina ricoperta da un filo d’olio e da una “mappina”, uno strofinaccio.
Mentre mia nonna aggiungeva il sale “a occhiu”, cioè senza bisogno di pesare la giusta quantità, mia zia Grazia provvedeva a prelevare l’acqua dalla “quadara” prestando attenzione alla temperatura. E in quel momento cominciava il bello. L’acqua cercava di trasbordare dal vulcanello e mia nonna, per evitare che si disperdesse, cercava di arginare quella specie di fiumiciattolo che si creava utilizzando il palmo della mano e della farina ancora asciutta.
La forza nei polsi doveva essere tanta se si desiderava ottenere un ottimo risultato, ma un ruolo fondamentale veniva giocato dall’esperienza. Infatti, a volte, mia zia voleva darle il cambio, ma lei puntualmente si rifiutava. Ottenuto un impasto liscio, omogeneo, utilizzando un coltello non dentellato, si procedeva con l’incisione di una croce, un rito, appunto, un momento che non poteva mancare durante la fase di lavorazione.
Credo che una breve orazione accompagnasse l’atto di baciare per tre volte lo squarcio a mo’ di croce che si veniva a creare sull’impasto. Fatto ciò si procedeva con la realizzazione dei pani: cudduri, vasteddi, a pistuluni, alcuni cosparsi di giuggiulena e altri no; mia zia lesta lesta li adagiava sul letto già pronto, avendo cura di lasciare lo spazio tra un pane e l’altro tenuto conto che di lì a poco si sarebbero gonfiati per la lievitazione. Man mano si coprivano con un telo bianco e delle coperte di lana.
Ricordo che quando le temperature erano davvero rigide si metteva una “bracera” con carboni ardenti nella stanza o in prossimità del letto per aiutare e accelerare il processo di lievitazione.
Terminato questo momento, si accendeva il forno a legna ovvero si “camiava”. Il forno di mia nonna aveva in cucina solo la “bocca” la porticina cioè attraverso cui si infilava la legna e le pagnotte crude; l’emisfero fatto in parte con mattoni pressati e in parte con “giaramiti”, ossia tegole rotte con maestrìa e fissati con gesso (jssu), si trovava all’esterno, in un cortiletto interno alla casa.
Si procedeva all’accensione della legna che doveva ardere bene da un lato, dal lato opposto e infine al centro. Quando “lu celu”, cioè la volta, diventava completamente bianca e “lu solu” i mattoni d’argilla che facevano da pavimentazione “sfaiddavanu”, ovvero lanciavano scintille se segnate con un bastone (furcuni), erano tutti segnali che indicavano che il forno era pronto. Si tiravano fuori i carboni ardenti e con una scopa di saggina (giummara), precedentemente immersa in acqua, si toglieva la cenere dalla base.
A questo punto era il momento di ‘nfurnari, di far cuocere il pane: un’operazione che si doveva fare con una certa celerità e, pertanto, si richiedeva l’aiuto di qualche vicina. Allora mia nonna mi diceva: – Va’ chiama a donna Nina o a la signura Fifidda e ci dici chi è ura di ‘nfurnari. Iddi lu sannu.
Io mi fiondavo da una o dall’altra a recapitare il messaggio. In due effettivamente era tutto più semplice. Mia zia Grazia scopriva i pani che, quasi per magia, si erano gonfiati, mia nonna ne percuoteva qualcuno per constatare che il processo di lievitazione fosse andato a buon fine e si piazzava con la sua pala in legno davanti la bocca del forno.
Nel frattempo mia zia, utilizzando una forchetta li pungeva con movimenti veloci, repentini (non ho mai capito il perché) e l’aiutante di turno iniziava il via vai dal letto al forno. Mia nonna li disponeva all’interno del forno avendo cura di distanziare bene i pani senza sprecare spazio. Per fare bene questo, spesso, si serviva di una candela accesa. Al termine si chiudeva la bocca con una specie di porticina di ferro chiamata “balata” dotata di un’impugnatura. Alcuni carboni ardenti venivano posti alla base della balata per aiutare a mantenere alta la temperatura del forno.
Tutte le volte che si preparava il pane mia nonna o mia zia mettevano da parte due “cuddure” cioè due belle pagnotte per fare l’arianata, la classica pizza siciliana, oppure il “pane fritto” passato nello zucchero. Io, bambino, speravo in cuor mio nell’arianata perché il pane fritto con lo zucchero non mi è mai piaciuto. Allora mi toccava aspettare e sperare. In ogni caso mi sarei rifatto con il pane “cunzatu” (olio e origano, semplice, oppure con l’aggiunta di pomodoro, formaggio o sarda) che si preparava appena veniva sfornato.
Il pane appena sfornato aveva un odore, un sapore e una fragranza particolari. Si gustava da solo, senza condimenti. Più volte mi è capitato negli anni di assistere alla sfornata del pane, di ripetere le stesse azioni di allora nella speranza di riscontrarvi quei sapori o quegli odori che si sono impressi, fissati nella mia memoria, ma ogni volta, con mia grande delusione, non li percepisco, non sono quelli della mia infanzia. Forse il tempo, “il vero pathos del decorso delle cose terrene, quel pathos che sempre scorre, che mai si esaurisce, che costantemente ci opprime e costantemente ci sostiene" (Erich Auerbach) avrà cancellato quelle sensazioni, ma non di certo i ricordi.
La foto è stata gentilmente concessa dal signor Antonino Crinelli